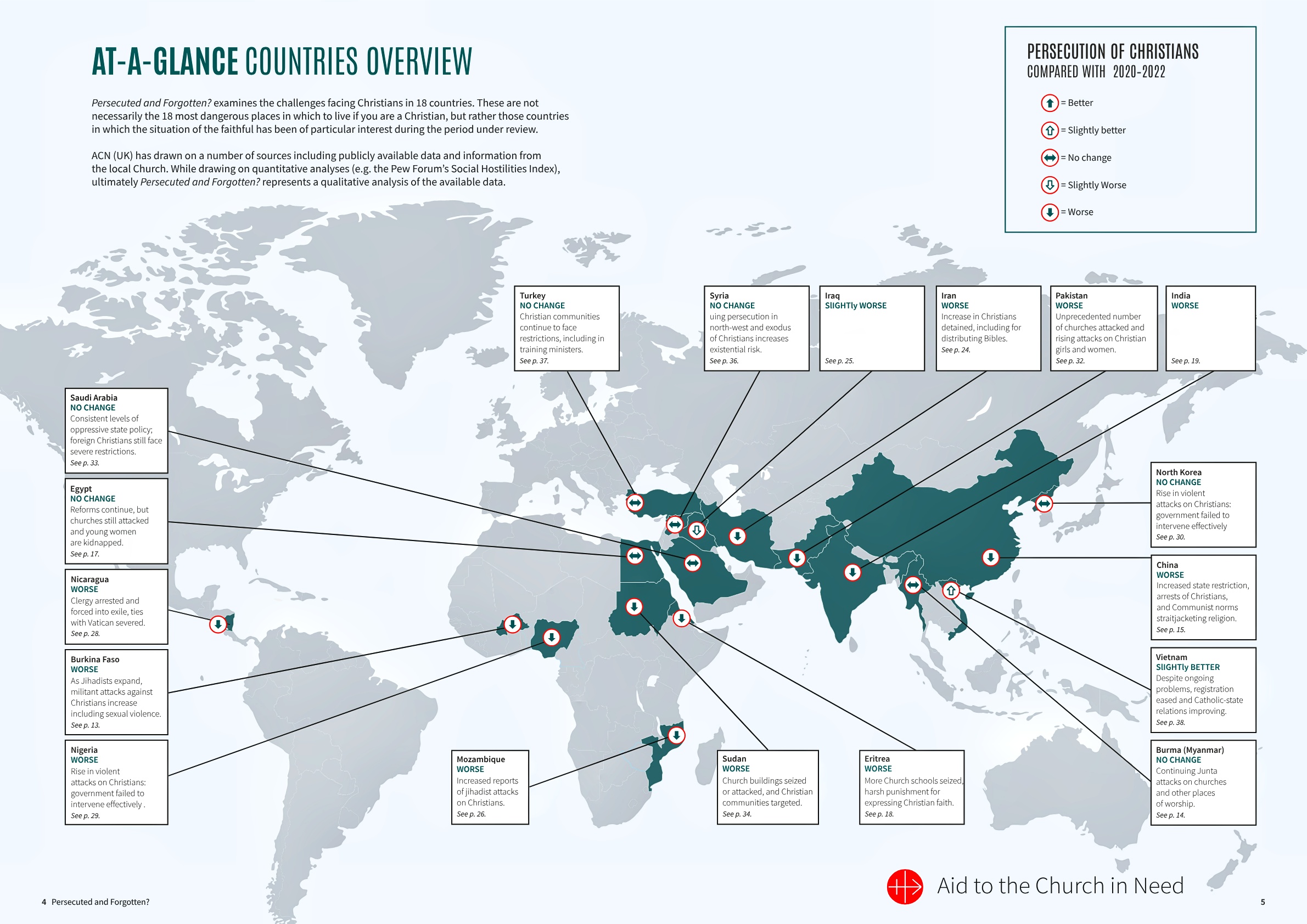Giacomo Leopardi e le Sacre Scritture
–
SUGGESTIONI BIBLICHE NELL’OPERA DEL GRANDE RECANATESE
Ci fu sempre un legame profondo tra Giacomo Leopardi e la Bibbia, suggestioni bibliche sono presenti in quasi tutte le opere del genio di Recanati. Molti studi, a cominciare dal grande critico Francesco De Sanctis, che per primo riconobbe la grandezza del poeta, hanno fatto emergere evidenti connessioni tra i testi leopardiani e le Sacre Scritture, nel contesto delle quali furono privilegiati soprattutto i libri di Giobbe e Qohelet, o Ecclesiaste, attribuito da Leopardi a Salomone. È ben risaputo che fra i ventimila libri della sterminata biblioteca del conte Monaldo suo padre (in gran parte comprata con le espropriazioni napoleoniche delle biblioteche ecclesiastiche) migliaia erano i testi religiosi e biblici, e su di loro il conte faceva esercitare i figli, Giacomo, Carlo e Paolina. Il giovane Leopardi studiò profondamente il greco e l’ebraico, e in queste lingue lesse e tradusse molti testi biblici.
Anche quando si allontanò dalla fede cristiana, intorno al ’20-’21, i grandi temi e le figure della Bibbia diedero forma e sostanza alla sua immaginazione e a molti suoi scritti, pur rimanendo inalterata l’impronta classicistica della sua sterminata cultura, Omero e i poeti greci, la letteratura latina, i poeti più amati, Petrarca e Tasso. Certo è, però, che la radicalità delle sue posizioni ideologiche pessimistiche, in particolare il male di vivere comune a tutti gli esseri umani, riprende, come sostiene Laura Novati in La Bibbia di Leopardi, “la maledizione del giorno della nascita di Giobbe, la certezza dell’infinita vanità che è soffio o fame di vento del Qohelet”. E anche, aggiungiamo noi, il continuo interrogare la luna e l’universo sul mistero della vita e della morte.
Le suggestioni bibliche sull’animo di Leopardi – mai così profonde in altri grandi intellettuali dell’Ottocento, nemmeno in Manzoni – hanno una relazione molto stretta con il fascino romantico per la poesia primitiva, quella, secondo la sua poetica, d’immaginazione e non di sentimento, per le favole e il meraviglioso che lo affascinavano fin da bambino, e gli episodi della storia sacra nutrivano e stimolavano la sua fantasia. Insomma, Omero e la Bibbia, “essendo i più antichi libri – scrisse nello Zibaldone – sono i più vicini alla natura, sola fonte del bello, del grande, della vita, della verità”. La Bibbia, poi, aveva un sublime fascino, quello di conciliare “l’immaginazione orientale e l’immaginazione antichissima”.
Lasciando da parte le numerose composizioni infantili scritte in latino, greco ed ebraico, che hanno il valore di pure esercitazioni letterarie, ripercorriamo – in modo invero succinto, ché occorrerebbero decine di volumi per analizzarle tutte, e di fatto esiste una straordinaria letteratura su questi temi – le più evidenti e significative suggestioni bibliche nei più famosi testi in prosa e in poesia del grande Recanatese, per poi concludere il nostro discorso analizzando più compiutamente il canto che la maggior parte dei critici ritiene la summa del pensiero leopardiano, il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.
Intanto, è doveroso precisare che, sugli episodi biblici, Leopardi non sempre dà un’interpretazione che corrisponde a quella cristiana o ebraica, comunque non per precisa volontà di adulterarne il significato, talvolta per adattarli al suo pensiero. Per esempio, nei passi dello Zibaldone o nelle poesie, nelle Operette Morali, egli dà risalto alle domande angoscianti di Giobbe, ma ci dice poco sulle risposte di Dio, tace sull’intervento provvidenziale di Dio alla fine del libro. Qua e là, sul Cristianesimo Leopardi sembra affermare che mortifica la ragione, o che, come sostiene il Timpanaro, egli interpreta in modo irrazionalistico il Cristianesimo, laddove egli addebita al Cristianesimo l’abbassamento della morale umana, perché prospetta ideali troppo elevati, probabilmente condizionato, non solo dai suoi mali fisici e psicologici, ma anche – forse soprattutto – dal becero Cristianesimo ultrarigorista di sua madre. In realtà, il pensiero di Leopardi verso Dio, l’aldilà e il Cristianesimo non è così radicalmente negativo, basterebbe leggere l’Epistolario del periodo napoletano e i documenti sulla sua morte, per avere posizioni più problematiche e meno indiscutibili.
D’altra parte, in un passo dello Zibaldone, Leopardi afferma che il peccato originale deriva da un uso eccessivo della ragione, cioè dal fatto che l’uomo volle andare oltre le conoscenze raggiungibili con la mente propria, volle superare ogni limite, nell’intento di apprendere tutta la scienza del bene e del male, anzi, di apprenderla solo con la ragione; da ciò Leopardi deriva che la ragione e la scienza sono fonti d’infelicità, opponendosi in questo modo all’Illuminismo, che riponeva una fiducia totale nella ragione e nella scienza. Perciò Leopardi non solo legge la Bibbia, ma ne trae interessanti meditazioni. E in altre parti, rilevò la forza interiore del Cristianesimo, che vivificò il pensiero ormai languido della civiltà greco-romana. Ama la Bibbia perché i popoli meridionali brillano nella filosofia (e in effetti anche in Italia la maggioranza dei più grandi filosofi proviene dal Meridione: da S. Tommaso d’Aquino a Vico, ai filosofi rinascimentali, sino a Gentile e Croce).
Detto questo, passiamo velocemente in rassegna queste suggestioni bibliche e cristiane in alcuni testi significativi dell’opera leopardiana.
Nell’Inno ai patriarchi hanno fine le esercitazioni dell’adolescenza, né patriarchi né profeti né figure evangeliche compaiono direttamente nella poesia leopardiana; qui vi è la nostalgia di un mondo soave e primitivo, del respiro della natura, la perdita della condizione paradisiaca è colpa soprattutto dei figli, del fraterno scempio di Caino agricoltore che si sobbarca il peso di Abele pastore, e risuona la maledizione di Giobbe, (3,3): pereat dies in qua natus sum/et nox in qua dictum est: conceptus est homo… Rivivono il mito dell’età dell’oro, il ritmo lento di quella lontana e perduta età, il dominio della natura incontrastata, e si annuncia la polemica contro i guasti della civilizzazione, permangono solo la sapienza di Salomone e la desolata protesta di Qohelet.
Nel Cantico del gallo silvestre, nelle Operette morali, che comincia con “Affermano alcuni maestri e scrittori ebrei che tra il cielo e la terra, o vogliamo dire mezzo nell’uno e mezzo nell’altra, vive un certo gallo selvatico… perocché si è trovato in una cartapecora antica, scritto in lettera ebraica, e in lingua tra caldea, targumica, rabbinica, cabalistica e talmudica…), molte sono le somiglianze con la lingua ebraica che Leopardi amava perché “poetica per difetto e mancamento, e perché la lingua scarseggiava di voci…”, una lingua dalla natura vaga e indeterminata, in sintonia con il ricorso alla vaghezza della sua poetica. Le immagini vane del risveglio, che riporta alla verità e a riprendersi la soma della vita, rievocano Qohelet, (1,3-9): “Tanto soffrire d’uomo sotto il sole/che cosa vale? Venire andare di generazioni/e la terra che dura/levarsi il sole e tramontare il sole…/quel che è stato sarà/quel che si è fatto si farà ancora/niente è nuovo/di quel che è sotto il sole”. E il Mortali destatevi del gallo, ripetuto, è solo un ristoro precario perché il morire è il solo intento della natura.
Il sabato del villaggio, forse l’idillio più bello, canta la vigilia della festa cristiana della domenica, giorno dedicato al Signore, è la vera festa perché contiene in sé l’attesa e la speranza, dove sono forse i versi più belli della poesia leopardiana, soprattutto nella descrizione dell’appressarsi della sera, piena di mutamenti di luce nel declinare del giorno, termina con una strofa, “Garzoncello scherzoso,/cotesta età fiorita/è come un giorno d’allegrezza pieno,/giorno chiaro, sereno,/che precorre alla festa di tua vita./Godi, fanciullo mio; stato soave,/stagion lieta è cotesta./Altro dirti non vo’, ma la tua festa/ch’anco tardi a venir non ti sia grave (vv.43-51), che rievoca l’Ecclesiaste: Ragazzo, goditi la giovinezza/va’ dove ti porta il cuore/e dove va lo sguardo dei tuoi occhi/ma sappi che per tutto/Dio ti giudicherà/e getta via il tormento del tuo cuore./Stràppati dalla carne il dolore/perché un soffio è la giovinezza/nerezza di capelli/un soffio. (Qo. 11,9-10).(Traduzione di Ceronetti). Va precisato, però, che l’invito alla gioia rivolto al fanciullo nel Qohelet si iscrive in una visione ciclica della vita umana che ha le sue stagioni e che conduce al male della vecchiaia, preludio della morte.
Echi simili sono presenti ne La sera del dì di festa, nella nostalgia che tutto finisce, anche i grandi imperi, ne Il passero solitario, figura del poeta che, solitario e malinconico, si contrappone alla festa. Il poeta che ritorna alla solitudine dolorosa sperimentata nella propria giovinezza, alla felicità e alla gioia non vissuta e di cui si pentirà, soprattutto per avere consumato la sua giovinezza negli studi. E qui ancora Qohelet: E il mio cuore ha veduto/grande sapienza grande intelligenza/e il mio cuore si è dato/a coltivar la sapienza/e a conoscere le passioni/e ho penetrato nella stupidità/anche questo è volere vento/grande sapienza è grande tormento/più intelligenza avrai/più soffrirai./ (Qo. 16-18).
Potremmo ancora continuare con i riferimenti biblici presenti in A se stesso, il più qoheletico dei Canti leopardiani (e l’infinita vanità del tutto, così finisce la poesia, riecheggiando sempre l’Ecclesiaste, Un infinito niente/tutto è vuoto niente, Qo. 1,1-2), nel Dialogo di Plotino e Porfirio, dove si affronta il tema del suicidio, ne I nuovi credenti, sarcastica derisione degli intellettuali napoletani che si convertono secondo la moda del tempo, nella Ginestra o il fiore del deserto, l’ultimo e più complesso dei Canti, il fiore gentile e profumato della ginestra che sopravvive in un mondo ostile, e che ci manda l’unico messaggio possibile, la solidarietà fra tutti gli uomini, che credono di essere creatori di un futuro pieno di progresso e sono invece nulla, un punto insignificante nei baratri dell’universo, un granel di sabbia rispetto alle sterminate galassie.
Ma è il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia la summa del pensiero leopardiano e anche la poesia che meglio racchiude la nostra idea, che stiamo cercando di dimostrare, le suggestioni bibliche nell’opera leopardiana. Il pastore che chiede alla luna le ragioni della sua noiosa esistenza e della sua infelicità, mentre il suo gregge inconsapevole è felice, è il fulcro della poetica e del pensiero leopardiano. Il grande critico Francesco De Sanctis, che conobbe Leopardi a diciannove anni nella scuola del Puoti a Napoli e che ne comprese subito la grandezza, disse che il Canto sembrava un “un poema biblico, una pagina di Giobbe”, certamente l’esito più alto, con quel pastore solitario che nella notte di uno spazio lontano domanda alla luna le ragioni del vivere terreno in un contesto di impassibilità e di lontananza dell’intero universo. Un salmo di pellegrinaggio tragico, senza senso e senza risposta. “Dimmi o luna a che vale/al pastor la sua vita,/la vostra vita a voi? Dimmi: ove tende/questo vagar mio breve/il tuo corso immortale?” (vv.16-20). E il Canto termina con un verso desolato e tragico, è funesto a chi nasce il dì natale.
Il tema centrale di questo Canto è quello della nascita, del primo pianto del bambino consolato subito dai genitori per il suo infelice “umano stato”. Il canto del pastore non è un grido di ribellione, è solo la dolorosa constatazione della disperata condizione umana. Leopardi senz’altro ebbe presente qui la terribile invocazione di Giobbe (3,3):
Perisca il giorno in cui nacqui
e la notte in cui si disse: “È stato concepito un uomo!”.
Quel giorno sia tenebra,
non lo ricerchi Dio dall’alto,
né brilli mai su di esso la luce.
Lo rivendichi tenebra e morte,
gli si stenda sopra una nube
e lo facciano spaventoso gli uragani del giorno!
Quel giorno lo possieda il buio
non si aggiunga ai giorni dell’anno,
non entri nel conto dei mesi.
Ecco, quella notte sia lugubre
e non entri giubilo in essa.
La maledicano quelli che imprecano al giorno,
che sono pronti a evocare Leviatan.
Si oscurino le stelle del suo crepuscolo,
speri la luce e non venga;
non veda schiudersi le palpebre dell’aurora,
poiché non mi ha chiuso il varco del grembo materno,
e non ha nascosto l’affanno agli occhi miei!
E perché non sono morto fin dal seno di mia madre
e non spirai appena uscito dal grembo?
Perché due ginocchia mi hanno accolto,
e perché due mammelle, per allattarmi?
Qui si conclude il nostro viaggio. È intellettualmente onesto adesso rilevare che il sentimento biblico della vanità in Leopardi si presenta con un significato diverso perché filtrato attraverso il materialismo e il pessimismo illuministico, mentre nella Bibbia questo sentimento nasce dal confronto tra il transitorio e l’eterno, tra il contingente e Dio. E per lo stesso Giobbe “militia est vita hominis super terram”. Resta il fatto, comunque, che il pessimismo illuministico si arricchisce nel Leopardi di implicazioni bibliche, realizzando una originale fusione tra conclusioni illuministiche e suggestioni bibliche. Questo fa sì che il pessimismo del Vecchio Testamento trasforma il dolore di Leopardi in una dimensione più cupa e profonda, e il dolore del grande Recanatese, spogliandosi di situazioni accidentali, contingenti, viene proiettato in una sfera senza tempo. L’educazione illuministica coniugata con la sensibilità romantica di Leopardi, con le sue vicende autobiografiche, dà al pessimismo leopardiano un sapore di antichità, di sacro, di universalità.
Tornando al Canto, se il pastore non conosce la violenza di Giobbe nel maledire il giorno della sua nascita, nel chiedere la morte già nel seno della madre, il suo canto di dolore incarna il tradimento che la vita perpetra rispetto a quel che promette, e se Giobbe accetta la vita come un destino senza che lui debba scontare una colpa, allora anche il pastore immobile vive il male di vivere, e lo accetta come un destino che ha l’unica spiegazione nel suo ciclico ripetersi, e il suo canto allora sgorga da una condizione religiosa, quasi mistica, in cui fa esperienza diretta di un infinito in cui non annega come annega Leopardi nell’Infinito, ma fa di quel paesaggio senza più spazio né tempo il suo vero paesaggio dell’anima. Ulteriore conferma di un’altra anima, quella leopardiana, se non razionalmente credente, profondamente mistica.