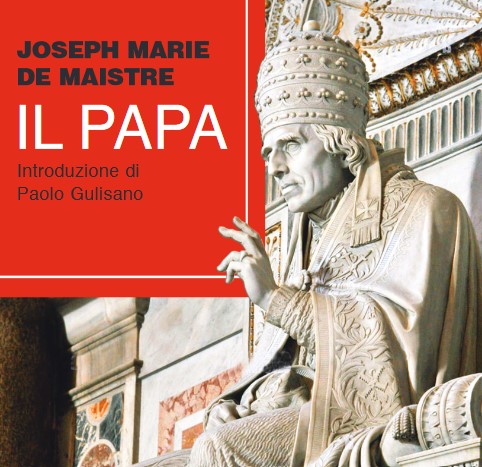Don Raffaele Aprile sull’obbedienza di Cristo, di Maria e del cristiano
L’UMILIAZIONE (TAPEINOSIS) OBBEDIENTE È UNO STILE DI VITA, UN MODO D’ESSERE NEI CONFRONTI DI DIO E DEGLI UOMINI, PIÙ CHE UNA CONDIZIONE SOCIALE O MORALE
–
Di Monsignor Mario Russotto*
Nato all’ombra e al servizio del Santuario regionale della Madonna delle Lacrime di Siracusa, il presente volume del carissimo don Raffaele Aprile – non nuovo a questa fatica di “lettura” della fede pensata e a volte anche poeticamente espressa – intende offrire uno studio agile e profondo sull’obbedienza.
Tale principiale virtù, insieme all’Amore fino allo spreco, è un pilastro fondamentale del cristianesimo. Essa si pone come una scala fra cielo e terra. E non sono angeli – come nella biblica notturna visione di Giacobbe nel deserto – quelli che la percorrono, bensì il Figlio di Dio in persona, incarnazione del “Deus descensus” obbediente al Padre ed elevazione dell’Uomo-Dio nella sua ascensione al cielo. In Lui, l’Autore presenta l’obbedienza come “via al cielo” di Maria Santissima, l’Immacolata, figlia della terra, pienezza del tempo nel quale «Dio mandò il suo Figlio nato da donna, nato sotto la legge» (Gal 4,4). E con lei anche i discepoli di Gesù – i “cristiani” – sono chiamati a percorrere l’itinerario ascendente dell’obbedienza in Cristo nel “fiat” di filiale accoglienza della volontà di Dio, vissuta come ascolto-risposta-impegno.
L’obbedienza: una via per il cielo, una virtù da riscoprire è il titolo della pubblicazione che don Raffaele Aprile ha scelto come tema e percorso di adesione alla divina volontà che, nella diversa ma comune obbedienza, unisce Cristo Gesù con Maria di Nazareth e il cristiano di ogni tempo.
Tre i fondamentali capitoli del libro che esaminano e approfondiscono, con acume e rigorosa attenzione ai testi biblici – quelli del Nuovo Testamento appunto –, il tema dell’obbedienza nella triplice tipologia dei personaggi suddetti. Ad essi si aggiunge un quarto capitolo, a mo’ di sintetica rilettura del tema trattato ma dall’angolazione della volontà di Dio.
I quattro capitoli sono racchiusi fra una introduzione e una conclusione, organicamente delineate, quasi un accompagnamento – mano nella mano – del lettore dentro la miniera biblica, per giungere allo sbocco dell’agostiniano interrogativo: «Si isti et illi cur non ego?». E questo mi pare sia proprio l’obiettivo dell’Autore… felicemente raggiunto in questo libro.
Ad impreziosire sostenere incoraggiare il cammino del lettore nel sentiero della non facile obbedienza, quale adesione alla Parola ascoltata studiata meditata, il volume riporta otto importanti e profondi contributi, rispettivamente di quattro ecclesiastici, tre dei quali Vescovi, e quattro laici: due uomini e due donne.
Calvino affermava: «Omnis cognitio Dei ab obœdientia nascitur», ogni vera conoscenza di Dio nasce dall’obbedienza, cioè dall’ascolto della Parola che invoca il “fare”, il mettere in pratica. E se l’ascolto è la sintassi della relazione, il silenzio è la grammatica della Parola: Essa esige ospitalità e obbedienza.
Custodia e memoria del Verbo abbreviato, la Bibbia sollecita una ermeneutica da parte del lettore credente, soprattutto attraverso l’esercizio sapienziale e attento del quotidiano ascolto: «Ascolta, Israele… tu amerai…» (Dt 6,4-5). Questo duplice imperativo è la sintesi di tutta la spiritualità ebraico-cristiana, che si caratterizza come spiritualità dell’ascolto agente. Per la Bibbia la fede nasce dall’ascolto (fides ex auditu). Esso richiede una apertura totale dell’uomo a Dio e una profonda disposizione di amore. Non esiste ascolto senza amore!
Amare Dio-ascoltare la sua voce-mettere in pratica la Parola sono tre aspetti di un’unica realtà, tre diverse formulazioni dell’obbedienza cristiana, quale vissuto di un unico fondamentale imperativo: «Ascolta… Amerai…». Perciò l’atto fondativo dell’obbedienza è il silenzio… interiore soprattutto. Perché solo nel silenzio può nascere e coltivarsi l’ob-audire. L’ascolto senza silenzio è semplice “audizione” di parole e suoni. Ma il silenzio senza ascolto è mutismo e solitudine. Abbiamo tutti continuamente bisogno di convertirci al silenzio interiore, per poter sapientemente ascoltare e responsabilmente obbedire.
«Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo corso, la tua parola… scese» (Sap 18,14). «Quando l’Agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz’ora» (Ap 8,1). Il Dio del silenzio pronuncia la sua Parola nel silenzio, sovente proprio con il silenzio. E solo nella nudità del silenzio orante può essere ascoltato accolto amato obbedito: «Il Padre pronunciò una parola, che fu suo Figlio, e sempre la ripete in un eterno silenzio, perciò nel silenzio essa deve essere ascoltata dall’anima» (S. Giovanni della Croce). Silenzio e Parola sono due movimenti della stessa partitura, due voci di uno stesso coro che si muovono intonando la melodia dell’obbedienza. E in essa, come in una danza, si avvicinano, si abbracciano… abbracciando la carezza dell’Altro nella grammatica della relazione.
«Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel Regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli… Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia…» (Mt 7,21-27). Gesù riconosce suoi discepoli soltanto coloro che fanno la volontà di Dio Padre (cfr. Mt 12,50; 21,29; Mc 3,35). Lui stesso, infatti, si presenta in tal modo, «perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato» (Gv 6,38).
La volontà del Padre non suscita tristezza; non giustifica tragedie, malattie, lutti, torri che crollano addosso ai costruttori… La volontà di Dio, insegnata e vissuta da Gesù, mette pace e serenità nel cuore, fa capire che nessun uomo è solo e ciascuno è chiamato a fiorire ad immagine di Dio, libero della libertà degli uccelli del cielo, radioso della bellezza dei gigli del campo, fratello e amico del Figlio e in Lui figlio amato del Padre delle misericordie.
Gesù non comanda scalate di vette impossibili, chiede soltanto di costruire la casa della vita sull’obbedienza alla Parola, ascoltata e accolta nel buon terreno del cuore: «Mettete in pratica la Parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché, se uno è ascoltatore della Parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio; e quando si è guardato se ne va, e subito dimentica com’era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato ma uno che la mette in pratica; egli sarà felice nel suo operare» (Gc 1,22-25). Ecco perché San Paolo ammonisce i cristiani di Efeso a vivere «con semplicità di spirito, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo» (Ef 6,6)
«Fate la volontà di Dio», in greco: «Poiountes tò thèlēma toù theoù» significa diventare “poietici”, anzi artigiani o artisti dell’obbedienza! Perché fare la volontà di Dio, cioè obbedire, è un’arte, una credente sapienza artigiana! Gesù apre nei suoi discepoli una crisi profonda: la crisi del dire! Perché solo nel fare la Parola di Dio, cioè nel ridare al Verbo il suo natale nella nostra carne, si può costruire solidamente la casa della propria vita. Ecco perché siamo chiamati a passare dall’essere uditori all’esserci essendo facitori della Parola, cioè artisti di obbedienza in piena consonanza con la volontà di Dio.
«Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa… La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse… E l’angelo partì da lei» (Lc 1,26-38). Raccontando l’annunciazione a Zaccaria, mentre svolgeva il suo servizio sacerdotale nel tempio, Luca scrive: «gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell’altare dell’incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò… Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria… capirono che nel tempio aveva avuto una visione…» (Lc 1,5-22).
Nell’annunciazione a Zaccaria c’è un angelo e c’è una divina “visione” da parte del sacerdote, quindi una teofania. Nel caso di Maria non ci sono due personaggi a confronto, l’uno di fronte all’altro, non c’è teofania (visione di Dio), quanto piuttosto una teofonia, un ascolto di Dio. L’angelo, infatti, «eiselthon pros autēn eìpen (entrando presso di lei disse)». E alla fine del dialogo, dopo il “fiat” obbediente di Maria, «apēlthon ap’autēs ò aggelos (andò fuori da lei l’angelo)». Dio si rivela e consegna la sua volontà a Maria non attraverso visione ma parola, richiedente ascolto in dialogo, non stando davanti a lei bensì entrando in lei: dentro di lei Dio immette il suo Vangelo! E accade una metamorfosi: in Maria il Vangelo entra in forma di Parola ed esce in forma di uomo! E questo in virtù della sua obbedienza e della sua piena adesione alla volontà di Dio che a lei si consegna.
Da Nazareth a Gerusalemme, dalla casa alla collina del Golgota si snoda l’obbedienza di Maria. E lì sul Calvario «stavano presso la croce di Gesù… “Donna, ecco il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!”. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa» (Gv 19,25-27). Maria soffre e medita, vede e piange, ama e offre… Lei non è soltanto “presso” la croce, ma è come inchiodata dalla comune obbedienza con il Figlio… sull’altro lato della croce!
Per Gesù è possibile “vedere” e “parlare” perché ci sono persone capaci di “stare” accanto a Lui nel silenzio e nell’accoglienza del suo incomprensibile mistero. Gesù non aveva risposto alle provocazioni e agli insulti dei passanti, ma ora guarda e parla… E pronuncia non una ma due parole, precisamente e distintamente alla Madre e al discepolo. Pur alle soglie della morte, quando bastava dire una sola frase per entrambi, Gesù formula due parole distinte: «”Donna, ecco il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!”» (Gv 19,26-27).
«Donna, ecco il tuo figlio!»: la Madre è chiamata “donna”, proprio come la prima volta in cui si parla di lei nel quarto vangelo, cioè alle nozze di Cana (Gv 2,4). E da allora Maria è stata la donna in attesa, la Sposa in avvento della gloria dello Sposo… Maria stava lì inchiodata in un silenzio accogliente, obbediente, aperto alla relazione. Stava… per lasciarsi interpellare… aspettando magari una inedita rivelazione: «Ecco il tuo figlio!». In Maria il suo stare provoca una dilatazione nella maternità: se all’inizio del racconto era «sua madre (di Gesù)», ora è «la tua madre (del discepolo)». In Maria lo stare presso il Figlio Gesù Crocifisso provoca una dilatazione del grembo, che accresce la sua capacità di accoglienza di un nuovo figlio, anzi di nuovi figli.
L’ultimo atto di Gesù, prima di morire, consiste nel distacco dall’ultimo legame alla terra, cioè da Maria sua Madre, e nell’ultimo estremo dono di questo legame all’umanità. La Madre di Gesù da quel momento diviene Madre dei discepoli, cioè Madre della Chiesa! E in Maria obbediente presso la croce la Chiesa nasce alla maternità crocifissa dell’obbedienza. La Chiesa è Madre! Quel rapporto d’Amore che esisteva tra la Madre e Gesù suo Figlio passa ora nella Chiesa. Assieme ad una dilatazione di maternità, in Maria c’è anche la capacità di lasciarsi accogliere. Anche la Madre, come il discepolo-figlio, ha bisogno di essere accolta, perché il discepolo partorisca Maria a nuova maternità e la Madre partorisca il discepolo a nuova figliolanza… nella comune obbedienza a Dio. Questa è la Chiesa! Maria e il figlio-discepolo amato ai piedi del Crocifisso, uniti nell’obbedienza a Cristo Signore, sono il punto di partenza e il punto di arrivo della Chiesa!
A Maria per divenire Madre del corpo fisico del Figlio di Dio erano bastate la sua grande fede, il suo “fiat” obbediente pieno di amore e la nuda povertà di Betlemme. Ma per divenire Madre del Corpo Mistico di Cristo è stata necessaria anche l’obbedienza nella sofferenza atroce del Calvario. A Betlemme, nella pace della notte e con gaudio immenso, Maria ha dato alla luce Gesù. Sul Calvario, tra le grida dei carnefici e con indicibile dolore, ha generato ogni discepolo alla vita della grazia. La maternità di Maria per l’umanità è maternità di amore e di dolore. Per essere suoi degni figli è necessario imparare da lei ad amare, a saper soffrire, ad essere fedeli nell’obbedienza a Dio fino al fine, al compimento, alla pienezza.
Facendo proprio un inno che probabilmente la comunità cristiana cantava nella liturgia, vera scuola della Parola e celebrazione orante del mistero di Cristo Gesù, San Paolo lo trascrive nella sua Lettera ai Filippesi (Fil 2,6-11), trovando in esso un’ottima sintesi del Vangelo di cui è infaticabile evangelizzatore. L’inno canta il cammino di discesa-ascesa di Gesù, un itinerario che ha il suo inizio in Dio e in Dio trova il suo estuario. Ma fra punto di partenza e punto di arrivo si dispiega tutta la vicenda di Cristo Gesù obbediente al disegno del Padre.
Sette sono i verbi che hanno per protagonista Gesù: tre all’indicativo aoristo per sottolineare le “tappe” del cammino (non considerò, spogliò se stesso, umiliò se stesso) e quattro al participio per spiegarne le modalità (assumendo la condizione di servo, divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, facendosi obbediente fino alla morte). Due sono i verbi che hanno per soggetto Dio Padre, ed entrambi si riferiscono all’esaltazione di Gesù: l’ha esaltato, gli ha dato il nome. Alla fine del canto due azioni vengono compiute da altri soggetti: ogni ginocchio, ogni lingua; il primo è esortato a piegarsi «nei cieli, sulla terra e sotto terra»; mentre il secondo è chiamato a proclamare che «Gesù Cristo è il Signore». E tale piegamento e proclamazione sono «a gloria di Dio Padre».
«(Cristo Gesù) Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio» (Fil 2,6). Il verbo “considerare” in greco è egeomai, che significa “guidare, condurre, discernere, giudicare”; mentre il termine “tesoro geloso” in greco è harpagmos, che di per sé significa “rapina, preda, bottino”. Gesù-Dio allora fa un ragionamento, opera un discernimento, arriva ad una valutazione: è uguale a Dio perché è Dio e tuttavia decide di non considerare un suo “bottino” tale uguaglianza con Dio, divenendo così l’anti-Adamo, il quale aveva cercato di “rapire” le prerogative divine, di farsi Dio (cfr. Gen 3,5).
La storia di Gesù è dunque esattamente all’opposto di quella di Adamo: se l’uomo aveva provato ad innalzarsi fino a Dio per “diventare come Dio”, Gesù-Dio si svuota di questa sua divina dimensione per abbassarsi fino all’uomo in una assunzione di solidale responsabilità. Il ragionamento in Dio non porta Gesù a tenere avidamente per sé il bottino della sua divina dimensione, bensì a valutare la sua incredibile decisione in termini di condivisione oblativa nella solidarietà più radicale.
«E il Verbo si fece carne e piantò la sua tenda in mezzo a noi» (Gv 1,14): così il prologo del vangelo giovanneo esprime il mistero dell’Incarnazione. L’inno paolino canta lo stesso evento affermando: «spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini» (Fil 2,7). Il verbo “spogliare” in greco è kenoo, mentre “assumere” è lambano e il sostantivo “servo” è doulos. Il doulos è uno che non si appartiene perché è di qualcun altro. E questa “appartenenza” alla dimensione e alla condizione umana Gesù non l’ha “assunta”, bensì l’ha volutamente presa e afferrata (lambano). Non è dunque la condizione umana ad essere entrata in Dio per assunzione, ma è Dio ad essere entrato da schiavo, e dunque da espropriato e svuotato di sé, nel mondo degli uomini.
E così Gesù, rinunciando al geloso “bottino” (harpagmos), cioè ai “privilegi” della sua dimensione divina, sposa per “svuotamento di sé” la dimensione umana… «divenendo simile agli uomini» (Fil 2,7). Quest’ultima forte affermazione indica che Gesù si fa uomo “normale” nell’aspetto e nel comportamento, nella finitudine e nella debolezza. Nella Lettera ai Romani San Paolo scrive che Dio ha mandato «il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e in vista del peccato» (Rm 8,3). E la Lettera agli Ebrei recita: «Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli… allo scopo di espiare i peccati del popolo» (Eb 2,16-17). La stessa Lettera in un altro brano afferma: «…non abbiamo un sommo sacerdote (Cristo Gesù) che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato» (Eb 4,5). In un testo dei primi tempi della Chiesa leggiamo: «Poiché la sua bontà fece piccola la sua grandezza, egli divenne come io sono» (Od. Sal 7,3s).
Il mistero dell’Incarnazione, secondo il nostro inno, non sta fra le due dimensioni divina e umana, bensì fra la “condizione di Dio” e la “condizione di schiavo”. Kierkegaard affermava che il paradosso del cristianesimo è l’Incarnazione, il nostro inno andava già ben oltre: il paradosso sta nel passaggio da Dio a schiavo, e dunque dall’appartenersi al non appartenersi, dalla pienezza allo svuotamento, dalla libertà all’obbedienza! Porsi più in basso dell’uomo fino a farsi schiavo a Gesù non basta, perché «umiliò se stesso (etapèinosen eauton)» (Fil 2,8). Il verbo greco tapeinoo significa “essere situato in basso”: socialmente in basso, cioè povero, privo di potere e di posizione sociale, insignificante, schiavo, non libero… Il verbo indica l’estremo opposto del potente, ricco, orgoglioso, dominatore. In generale nel mondo greco la condizione di inferiorità, espressa con il termine tapeinos, è una vergogna da evitare.
Ma proprio questa vergogna è sposata da Dio, è vissuta da Maria che nel suo Magnificat canta: «Ha guardato l’umiliazione (tapeinosis) della sua schiava (doulè)… ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umiliati (tapeinous)» (Lc 1,48.52). Anche Giovanni Battista, preparando la venuta del Messia, proclama: «Ogni burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle sia abbassato (tapeinosetai)» (Lc 3,5). E infine Gesù, lo schiavo svuotato di sé per amore, invita tutti a seguirlo nella sua via di umiliazione: «Imparate da me, perché sono mite e dal cuore umiliato (tapeinos)» (Mt 11,29).
«Umiliò se stesso» indica dunque che Gesù ha sposato la debolezza e la limitatezza del vivere umano in tutta la sua fragilità e il suo condizionamento, nella provvisorietà e frammentarietà. E da Gesù, lo stesso San Paolo impara a vivere in “umili” condizioni (patire la fame, la povertà, le privazioni…), ad “abbassare se stesso” tanto da poter affermare: «Ho servito il Signore (lett. Sono stato schiavo del Signore) con tutta umiltà (tapeinophrosyne), tra le lacrime e tra le prove» (At 20,19). E nutre la speranza che il Signore «trasfigurerà il nostro misero corpo (lett. il corpo della nostra tapeinosis) per conformarlo al suo corpo glorioso» (Fil 3,21).
L’umiliazione (tapeinosis) obbediente è dunque uno stile di vita, un modo d’essere nei confronti di Dio e degli uomini, più che una condizione sociale o morale. L’antica tentazione: «Diventerete come Dio» è da sempre nell’uomo. Egli cerca di salire: avere di più, contare di più, sapere di più, godere di più, vivere di più. Essere il primo e ricevere onori è il suo grande sogno. In un mondo in cui il vecchio Adamo rinasce in ogni uomo, Gesù viene come l’uomo nuovo. Va nel senso opposto: si umilia per obbedienza fino alla vergogna della schiavitù. Scende in basso il Solo che sta in alto! Ma non è tutto. Alla dimensione di schiavitù e di umiliazione, Gesù aggiunge appunto quella dell’obbedienza: «facendosi obbediente» (Fil 2,8).
“Obbediente” (ypekoos) in greco è composto dalla preposizione “ypo” (sotto) e dal verbo “akouo” (ascoltare), allo stesso modo del corrispondente latino ob-audire, letteralmente: stare sotto l’ascolto. Nell’Antico Testamento greco il verbo traduce l’ebraico shammàh, che significa ascoltare-obbedire. Per l’ebreo, il vero ascolto mette in moto tutto l’essere, porta all’obbedienza, che diventa piena risposta alla rivelazione. L’obbedienza suppone dunque l’ascolto. Anche Dio ascolta l’uomo e gli obbedisce: «Prima che mi invochino, io risponderò; mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati» (Is 65,24).
L’obbedienza non indica primariamente un comportamento morale, ma la nuova condizione del cristiano, cioè l’atteggiamento positivo di accoglienza della Parola. Lo svuotamento e la discesa di Gesù apparentemente non sono spiegati. Ma il «divenendo obbediente» fa intuire che Gesù compie questo percorso in ascolto del Padre. Il suo abbassamento è la conseguenza di un ragionamento e di una decisione di obbedienza. Gesù ha vissuto la sua discesa in fiducia al Padre fino all’ultima soglia, quella in cui la vita sfugge irreparabilmente: la morte. Ha saputo dire sì anche quando questo gli strappava l’ultima cosa rimasta, l’ultimo soffio. Nessuno è più libero del Figlio obbediente al Padre fino alla morte!
Svuotato di sé, schiavo, umiliato, obbediente: ecco le quattro caratteristiche vissute da Gesù nel suo cammino discendente, nel suo essere-con-noi, uno come noi, uno per noi. Ma non è ancora il culmine. L’inno, infatti, presenta il punto d’arrivo dell’umiliazione obbediente di Gesù: «fino alla morte e alla morte di croce» (Fil 2,8). In greco abbiamo mechri thanatou, thanatou dé staurou (obbediente sempre, per tutta l’estensione della sua vita) fino a morte, ma… morte di croce!
Ci fu e ci sarà mai obbedienza più radicale, totale, incondizionata, sacrificale? Tutto in Lui è dono d’amore, anche l’obbedienza fino all’ignominia della croce è dono d’amore! La morte di croce è il compimento dell’obbedienza di Gesù al Padre e causa della sua esaltazione, quale risposta del Padre al Figlio obbediente. La croce è il punto d’arrivo, il crinale della solidarietà di Gesù con l’ultimo degli uomini, l’approdo del suo cammino di svuotamento, umiliazione, schiavitù d’amore. Non è perciò un evento casuale o isolato, ma l’estuario di quel ragionamento in Dio che ci mostra e dimostra fino a che punto Gesù «non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso… fino… alla morte di croce» (Fil 2,6-8).
Al centro dell’inno c’è dunque Uno morto sulla croce: contemplando Lui, San Paolo nel buio della sua prigione canta e riscrive questo straordinario inno. È stato affascinato dal Cristo Crocifisso, dal quale ha compreso un fatto essenziale: «Mi ha amato e ha dato se stesso per me» (Gal 3,20). Così non può più pensare se stesso se non conformato a Lui: «Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). Vede con gioia il suo cammino d’apostolo configurarsi a quello del Crocifisso; poco oltre il nostro inno afferma: «E anche se il mio sangue deve essere versato in libagione sul sacrificio e sull’offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi» (Fil 2,17).
La croce è l’estuario dell’itinerario discendente di Gesù, l’ultimo suo atto di volontaria umiliazione e obbedienza: «pur essendo Figlio, imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose che patì» (Eb 5,8). Ma non è l’ultima parola di Dio! «Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome» (Fil 2,9). La morte non è la parola definitiva di Dio, ma il punto estremo dello spogliamento e dell’incarnazione del Figlio, crocevia “necessario” per l’esplosione della Vita e il superinnalzamento della Verità dell’Amore e del Nome che salva: «Non possiedo né argento né oro – dice Pietro allo storpio – ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!» (At 3,6).
«Per questo Dio l’ha esaltato»: in greco abbiamo la preposizione yper (super, sopra) e il verbo hypsoo. Questo verbo significa “estendere verso l’alto, rendere superiore, elevare”. Il suo opposto è la tapeinosis, l’umiliazione. Poiché Gesù «non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma… umiliò se stesso (etapèinosen eauton)», il Padre ora lo super innalza da questa umiliazione. Per l’Antico Testamento, elevare l’uomo è prerogativa esclusiva di Dio: Dio eleva i giusti, cioè coloro spesso oppressi che gridano a Lui. Il verbo hypsoo può indicare anche il gesto con il quale il padre riconosce il figlio elevandolo a tale dignità. Nel Nuovo Testamento il verbo hypsoo ricorre venti volte e significa “rendere grande, elevare, esaltare”. Per sette volte Gesù ne è il destinatario. Nelle prime asserzioni cristologiche, la risurrezione e l’elevazione di Gesù sono considerate come un tutt’uno. Nel nostro inno l’elevazione di Gesù appare come una conseguenza della sua obbedienza nella sofferenza e consiste nell’investitura della sua funzione di “Signore” sul cosmo intero.
Alla discesa di Gesù fa seguito, come conseguenza ma con un aspetto anche di successione temporale, la sua elevazione. Il Padre attende che Cristo compia per intero il suo percorso di obbedienza e di fiducia per costituirlo Signore dell’universo. Cristo non recupera semplicemente la situazione iniziale, ma trascina con sé quell’umanità dispersa che andava per le proprie strade (cfr. 1Pt 2,25; Gv 11,52) e l’intero universo perché, riconoscendolo Signore, dia gloria al Padre (cfr. Ef 1,14). La riflessione successiva degli evangelisti Luca e Giovanni fa intuire che la “discesa” era in se stessa una “salita”, in quanto era l’espressione massima dell’amore obbediente di Gesù al Padre.
«Per questo Dio l’ha esaltato»: la croce è dunque la rivelazione di chi è Dio. Sulla croce si vede un Dio che ama oltre il necessario. Il gesto del Padre che dona il Figlio e del Figlio che dona se stesso in quel modo non è misurato sul bisogno dell’uomo, ma sulla ricchezza dell’amore di Dio. La croce mostra che la via dell’obbedienza è vittoriosa. Sembra perdente, ma è vittoriosa. Per questo la croce è Vangelo, è la prima ineludibile faccia della medaglia del kerygma cristiano: «Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture» (1Cor 15,3-4).
La risurrezione è il segno che la via dell’obbedienza a Dio e del dono di sé nell’Amore è vincente, è una grande lieta notizia. Bisogna tenere presente però che è essenziale mantenere l’identità tra il Crocifisso e il Risorto. Perché la croce non è semplicemente l’icona di un martire qualsiasi rimasto obbediente e fedele a Dio fino a dare la vita per Lui, ma è l’icona di un martire con un volto preciso: il volto di Gesù di Nazareth, cioè il volto di un uomo che ha predicato e mostrato un Dio diverso e per molti scandaloso. Questa diversità è stata la ragione della sua condanna a morte, ma Lui ha sostenuto che era, al contrario, la trascrizione più fedele del volto di Dio. La resurrezione-esaltazione è la prova che in quella diversità Dio si è riconosciuto.
Dio Padre non si limita a super innalzare Gesù a causa della sua umiliazione obbediente fino alla morte di croce ma va ben oltre, dando un fine a questa esaltazione: «e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore» (Fil 2,9-11). All’atto dell’esaltazione si aggiunge il “regalo” (in greco echarisato) del nome. Charis è grazia, dono; il verbo greco indica la gratuità del dono. Due sono pertanto le azioni di Dio Padre in risposta all’obbedienza del Figlio: superesaltazione e supernome. Ed esse hanno una finalità che corrisponde ad una terza duplice azione da parte delle creature: l’adorazione («ogni ginocchio si pieghi») e la proclamazione della signoria di Gesù («ogni lingua proclami»).
Abbiamo così una liturgia cosmica costituita dall’adorare e proclamare, cioè dalla celebrazione del riconoscimento di Cristo Gesù Pantocratore e Signore dell’universo intero («nei cieli, sulla terra e sotto terra»). Ma questa sinfonia liturgica si apre anche ad una universale evangelizzazione, alimentata dalla preghiera adorante e contemplativa («ogni ginocchio si pieghi») e dall’annuncio coraggioso esplicito diffuso del Vangelo di Gesù Cristo («ogni lingua proclami»). La proclamazione è riconoscimento del nome nuovo di Gesù: Kyrios (Signore), che è il modo greco di dire l’impronunciabile nome di Dio rivelato a Mosè sul monte Sinai: YHWH. Il Fedele e Verace condottiero di giustizia dell’Apocalisse, ultimo libro della Bibbia, «porta un nome scritto sul mantello e sul femore: Re dei re e Signore dei signori» (Ap 19,16). «L’invocazione liturgica di Gesù come Signore è una delle confessioni più antiche, se non la più antica, della fede cristiana. Con essa, la Chiesa… si sottopone al suo Signore, professando anche il suo dominio sul mondo… Da quando Gesù è stato innalzato a Kyrios, tutte le potenze devono essere sottomesse a lui e servirlo» (H. Bietenhard).
All’obbedienza discendente di Gesù risponde il dono ascendente del Padre, e in questo reciproco gratuito darsi si inserisce l’universo intero e ogni creatura con una liturgia cosmica «a gloria di Dio Padre» (Fil 2,11). Perciò «abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina…» (Fil 2,5-6). Nella catechesi su San Paolo all’udienza generale del 13 giugno 2005, Benedetto XVI ha detto: «Entrare nei sentimenti di Gesù vuol dire non considerare il potere, la ricchezza, il prestigio come i valori supremi della nostra vita, perché in fondo non rispondono alla più profonda sete del nostro spirito, ma aprire il nostro cuore all’Altro, portare con l’Altro il peso della nostra vita e aprirci al Padre dei Cieli con senso di obbedienza e fiducia, sapendo che proprio in quanto obbedienti al Padre saremo liberi. Entrare nei sentimenti di Gesù: questo sarebbe l’esercizio quotidiano da vivere come cristiani».
Congratulandomi con don Raffaele Aprile per questo suo prezioso e rigoroso studio sull’obbedienza di Cristo, di Maria e del cristiano, auguro una feconda diffusione della presente pubblicazione, perché tanto bene farà ai lettori e tanta luce diffonderà nella Chiesa. Le lacrime della Madonna, gioiosamente obbediente, siano un “fiat” di speranza e di consolazione per tutti coloro che, ricorrendo a lei, ne seguono le orme coniugando amore e obbedienza, parola e silenzio, ascolto e impegno.
* Vescovo di Caltanissetta
Introduzione al libro di don Raffaele Aprile
“L’obbedienza. Una via per il Cielo, una virtù da riscoprire“