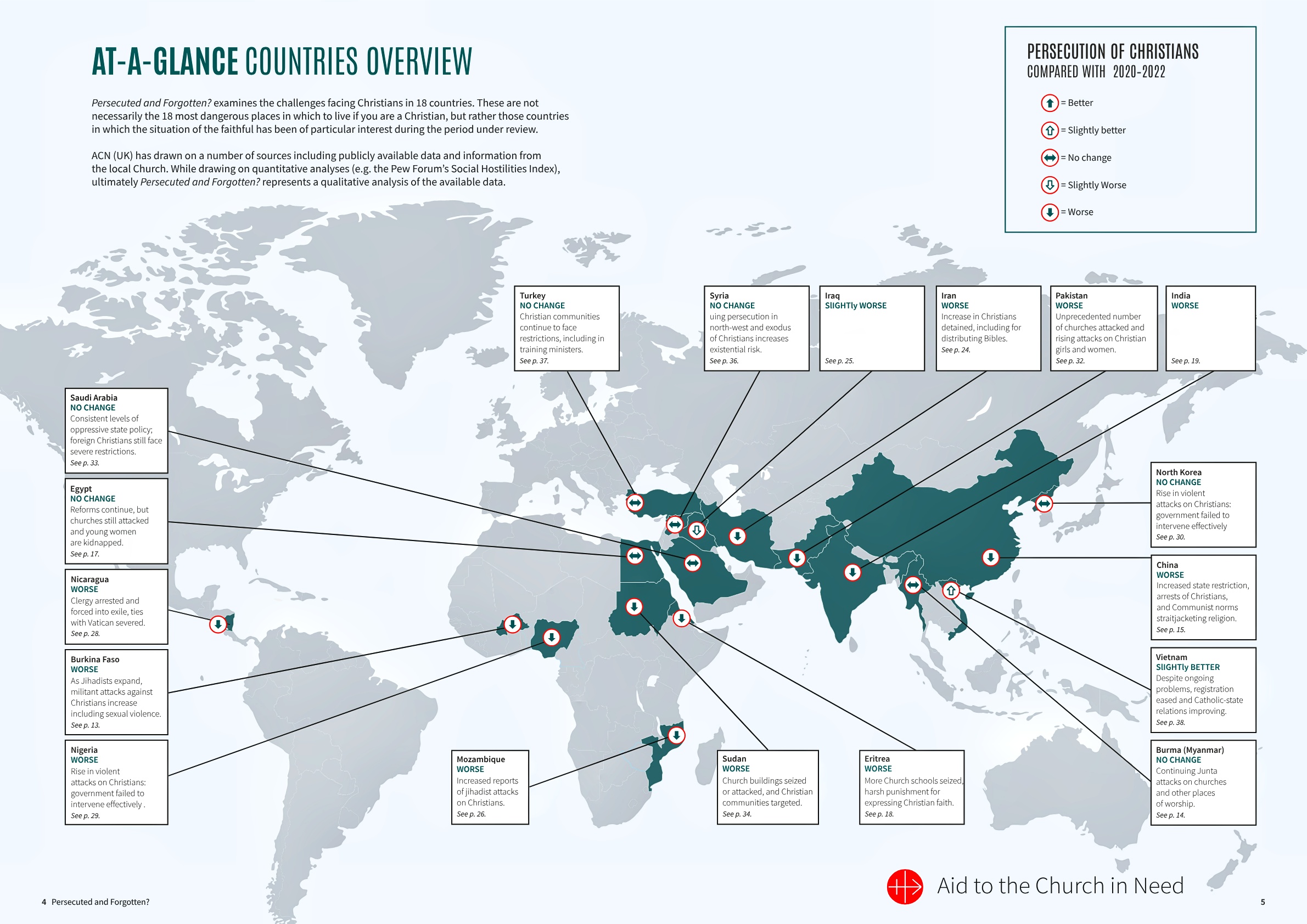L’ultimo Gattopardo, incontro con Gioacchino Lanza Tomasi
di Francesco Bellanti
–
LETTERATURA, STORIA, POLITICA, RELIGIOSITÀ, NOBILTÀ, SICILIA, DESTINO, IN UN INCONTRO MEMORABILE
Quel tredici dicembre 2021 – era un lunedì – era una giornata piovosa, grigia, fredda. Qualche mese prima era stato pubblicato il mio libro su Isabella Tomasi, (Isabella Tomasi di Lampedusa – La più grande dei Gattopardi, Carello Edizioni, Catanzaro), e ritenni giusto regalarne due copie all’ultimo discendente della famiglia, anche se adottato, il professore e principe Gioacchino Lanza Tomasi. Mi diede il numero di cellulare una mia carissima amica, un’intraprendente dirigente scolastica che era una sua cara amica e lo aveva ospitato più volte nella sua scuola per eventi culturali e per avere intitolato la stessa scuola al grande scrittore del Gattopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, padre adottivo del professore. Dieci giorni prima avevo mandato un messaggio al numero del professore, mi rispose la segretaria. Al telefono poi concordammo quel giorno, perché il famoso musicologo era fuori per impegni. Col treno da Agrigento, io e mia moglie giungemmo a Palermo dopo un paio d’ore, intorno alle undici di mattina. Nonostante la pioggia, girammo un po’ per il centro, via Maqueda, via Roma, la Vucciria, poi scendemmo verso il quartiere storico Kalsa, dove, vicino al Foro Italico, in via Butera, era il palazzo nobiliare dell’illustre uomo che ci doveva accogliere. Dopo aver pranzato in un ristorante vicino, davanti al mare (spaghetti con le vongole e pescespada ai ferri, se non ricordo male), intorno alle quindici ci avviammo verso il palazzo del principe. Ci aprì il bel portone nobiliare una gentile segretaria.
Diversi amici mi avevano parlato – ma in modo superficiale – di questo grande uomo, perché lo avevano incontrato a casa sua o in avvenimenti pubblici. Lo chiamavano “il principe”, e io un po’ mi arrabbiavo perché la Repubblica Italiana non riconosce più i titoli nobiliari. Perciò la prima cosa che chiesi alla sua segretaria, entrando con mia moglie nel palazzo di Gioacchino Lanza Tomasi, fu se dovevo chiamarlo principe o professore, per evitare che si offendesse, e la segretaria mi disse che solo i miei concittadini lo chiamavano principe. Confortato, seguii la segretaria con mia moglie.
Chissà, pensavo, quante persone importanti sono venute qui per incontrare l’ultimo dei Gattopardi, il giovinotto investito di un destino così grande, il custode e il promotore dell’eredità culturale di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, lo scrittore del Gattopardo. Scrittori, poeti, intellettuali, politici, registi come Luchino Visconti, di cui fu consulente all’epoca del famoso film.
Navigando fra questi pensieri, dopo pochi minuti e un breve tragitto di scale e sale, ci trovammo di fronte al famoso Gioacchino Lanza Tomasi, il figlio adottivo dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l’autore del celebre romanzo “Il Gattopardo”. Sì, avevamo davanti il professore di Storia della musica all’Università degli Studi di Palermo, il direttore dell’Istituto Italiano di cultura di New York, il sovrintendente del Teatro di San Carlo di Napoli, il componente della Commissione Musica della Biennale di Venezia, il professore di Storia della Musica presso l’Università di Salerno, il direttore artistico dell’Opera di Roma, del teatro Comunale di Bologna, il consulente del teatro Massimo di Palermo e del teatro Comunale Vittorio Emanuele di Messina, il direttore artistico del Festival Verdi. Avevamo davanti il Presidente della Fondazione Tomasi di Lampedusa e del Premio Letterario intitolato al suo genitore adottivo, il grande musicologo e critico musicale di tanti prestigiosi giornali, che aveva ricevuto numerose onorificenze internazionali, lo storico delle ville, dei castelli e dei Monasteri siciliani, dei luoghi del Gattopardo, lo scrittore di storia dell’arte e storia della musica, il massimo studioso del teatro d’opera e dell’evoluzione del melodramma nel teatro contemporaneo, e naturalmente il biografo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e, come detto, il consulente di Luchino Visconti per il film Il Gattopardo. Nella sua lunga vita, praticamente è stato tutto.
Quando lo incontrammo, navigava verso gli ottantotto anni, essendo nato a Roma l’11 febbraio 1934, (morirà a Palermo il 10 maggio 2023). Avevamo davanti anche un nostro concittadino, avendo il professore ricevuto nel 2018 la cittadinanza onoraria di Palma di Montechiaro. Gioacchino Lanza Branciforte Ramírez era il figlio terzogenito del senatore Fabrizio Lanza Branciforte Ruffo, conte di Mazzarino e di Assaro, e di Conchita Ramírez Camacho, figlia ed erede di Venceslao marchese di Villa Urrutia. Si trasferì con la famiglia a Palermo dopo la Seconda guerra mondiale. La famiglia paterna discendeva dagli Svevi che giunsero in Sicilia quasi un millennio prima, alla corte dell’imperatore Federico II. In quegli anni iniziò la frequentazione, insieme ad altri giovani intellettuali palermitani di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, suo lontano cugino, cui restò vicino negli ultimi tre anni di vita e dal quale nel 1957 venne adottato, assumendo quindi il cognome “Lanza Tomasi”.
Quando Gioacchino Lanza fu adottato, il principe Giuseppe Tomasi era povero e nessuno lo conosceva, tranne qualche amico e tre giovani – uno di questi era il futuro figlio adottivo – che frequentavano la sua casa. Il principe Tomasi viveva in ristrettezze, perché la famiglia, un tempo gloriosa e ricchissima, era in rovina. Così disse anni dopo Gioacchino Lanza Tomasi. Lui e altri due amici, Francesco Orlando e Francesco Agnello, in quei primi anni Cinquanta, a Palermo, raggiungevano il Tomasi al caffè Caflish o al bar Mazzara, e s’immergevano in lunghe discussioni letterarie, che poi continuavano in via Butera, nel palazzo del principe, due volte a settimana. Fu un’adozione sorprendente, quella di Gioacchino Lanza, nella quale pesò molto il giudizio della moglie del principe, “Licy”, al secolo Alexandra Wolff Stomersee, la prima donna in Italia a occuparsi di psicoanalisi. E, infatti, nel tratteggiare il personaggio di Tancredi ne “Il Gattopardo”, è noto che il principe si è ispirato in parte a lui. Io comunque avevo già deciso di non chiedergli nulla dei personaggi del romanzo e della storia della pubblicazione postuma a opera dello scrittore Giorgio Bassani, nel 1958, universalmente nota, né della triste e tragica fine del principe per un tumore ai polmoni a casa della cognata a Roma, nel luglio del 1957.
Lo trovammo vestito con giacca marrone e pochette, indossava un maglioncino grigio, e una camicia chiara della quale s’intravedeva solo il colletto, pantaloni beige, calze blu scuro, scarpe sportive blu. Nella mano sinistra, all’anulare aveva un bell’anello rotondo. Alla sua sinistra c’erano molti dischi di musica classica, sinfonica, opere liriche. Due grandi finestre si affacciavano sul mare palermitano. Ci accolse in una stanza con un grande salotto, lui seduto in una poltrona grigia e con un bastone accanto. Un tavolino con mascherina, alcune foto. Molti quadri, come in tutte le camere dell’elegante palazzo, pavimento in parquet di legno chiaro, tetto in legno con travi.
Percepii subito la presenza di un uomo superiore, con un formidabile carico di storia alle spalle. In ogni parola, in ogni memoria, in ogni gesto si percepiva il senso di un testamento morale, storico, la sensazione dell’addio alle cose terrene. Il prossimo febbraio presenterò il libro a Palma di Montechiaro, gli dissi durante la conversazione, mi piacerebbe tanto che lei ci fosse. A febbraio compirò ottantotto anni, mi rispose, se sarò ancora in vita si metta d’accordo con la mia segretaria.
Ci presentammo. Lui ci disse di sedere davanti a sé, e la segretaria sedette al nostro fianco. Durante la conversazione, lei e mia moglie intervennero con pudore, con brevi frasi. In breve, gli dissi che ero un professore di lettere in pensione che stava pubblicando libri che aveva scritto e che stava scrivendo, e che, avendo scritto un libro sulla sua famosa antenata, la Venerabile Suor Maria Crocifissa della Concezione al secolo Isabella Tomasi, la Beata Corbera del Gattopardo, aveva pensato di fare cosa gradita regalandogli due copie del libro. Gli diedi anche un chilo di biscotti ricci di mandorla del mio paese, di cui si parla anche nel romanzo, lui ringraziò con occhi luminosi. Grazie, disse, vedo che sono di una pasticceria palmese. Ha fatto bene, al Monastero i biscotti ricci non li sanno più fare, e non perché li fanno le romene. Detto ciò, diede i biscotti ricci alla segretaria, che li poggiò su un tavolino.
Bellissimo palazzo. Sì, disse il professore. E siamo nel quartiere più bello di Palermo, nel centro storico. Conosco bene Palermo, dissi, vi ho studiato all’università. Mi sono laureato con lode con Antonino Buttitta. Ah, bene. E continuò. È conosciuto come Palazzo Lanza Tomasi, e siamo nel cuore del quartiere Kalsa, la famosa araba Halisa, la cittadella eletta degli Emiri. È un palazzo della fine del Seicento costruito sulla Mura delle Cattive, i noti bastioni spagnoli cinquecenteschi, fu edificato sulle casematte militari retrostanti le mura cinquecentesche della città. Eh sì, professore, e si affaccia su uno splendido lungomare, il più bello di Palermo. Con tutte queste luminose finestre della facciata, sono dodici, mi pare, e la lussureggiante terrazza. Sì sente sempre un profumo inebriante, continuò Gioacchino Lanza, è un vero e proprio giardino pensile ricco di essenze mediterranee e subtropicali. Agli inizi del Settecento, nel 1728, i Padri Teatini lo adibirono a Collegio Imperiale per l’educazione dei nobili, Collegio che fu chiuso nel 1768. Poi il palazzo fu acquistato da Giuseppe Amato, Principe di Galati, che unificò in un unico prospetto di stile vanvitelliano la facciata sul mare. Nel 1849 passa ai Tomasi. Lo acquista, infatti, il Principe Giulio Fabrizio di Lampedusa, l’astronomo dilettante, il protagonista del Gattopardo del pronipote Giuseppe, don Fabrizio, con l’indennizzo che gli fu versato dalla corona per l’espropriazione dell’isola di Lampedusa. Una famiglia di armatori, i De Pace, parenti dei Florio, nel 1862, acquista metà del palazzo e la trasforma secondo il gusto del tempo. Con i materiali di risulta dalle demolizioni per la costruzione del Teatro Massimo si realizza il grande scalone, e si costruisce la grande sala da ballo con parquet a doghe portanti di noce e ciliegio alternate. È nel 1948, mi pare, gli dissi, che Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che aveva perso il palazzo di famiglia a causa dei bombardamenti del 1943, ricompra la proprietà dai De Pace, e quindi vivrà qui fino alla morte. È lei, poi, che riunifica tutta la proprietà e restaura tutto l’edificio.
Bellissimo palazzo, sì. La segretaria, dopo la conversazione, che durò più di un’ora, ci fece visitare tutto il piano nobile, con mobili e arredi tipici delle grandi dimore patrizie, della migliore ebanisteria siciliana. Dove visse lo scrittore. Una casa museo. La segretaria fu molto gentile, ci fece visitare tutte le stanze del bellissimo palazzo, la sala del ventaglio, la bellissima biblioteca, i quadri di Isabella Tomasi, del Gattopardo storico. Stanze pulite, ordinate anche se piene di oggetti, e luminose. Bellissimi lampadari, tante sedie, poltrone e divani di pregio. Le foto pubblicate sui giornali non comunicano il respiro esatto della storia e della bellezza che si sente camminando per quelle stanze. Tanta luce entrava dalle ampie e alte finestre. Si sentiva anche il profumo del mare. Splendidi arazzi e parquet in quasi tutte le stanze. Consolle rococò con ceramiche di gran pregio, tavoli intarsiati, lunghi tavoli con sedie in pelle color granata o viola. Abbiamo visto nella sala da ballo il manoscritto completo del Gattopardo, il dattiloscritto, altri manoscritti di racconti e di lezioni di letteratura francese e inglese, e, in un’ala del palazzo, i ritratti degli antenati dello scrittore, tra i quali quello del bisnonno Principe Giulio Fabrizio Tomasi di Lampedusa, Giulio IV, il Gattopardo. Poi soffitti affrescati, e in una sala una splendida collezione di ventagli francesi del Settecento, in un’altra la cosiddetta Sala del Mediterraneo con una straordinaria collezione di carte nautiche inglesi di fine Ottocento. I mobili e i quadri, quelli dello scalone monumentale, delle sale d’ingresso e della biblioteca storica, sono del distrutto Palazzo Lampedusa e del palazzo di Santa Margherita di Belice, la residenza estiva dei Filangeri di Cutò, la famiglia materna dello scrittore, poi distrutta dal terremoto della Valle del Belice nel 1968. Altri arredi del piano nobile provengono da collezioni e da palazzi nobiliari i cui proprietari erano imparentati con i Tomasi e con i Lanza.
Lo leggerò, disse, sfogliando il libro con cura. Mi sembra diverso dagli altri, tranne uno di natura storico-antropologica, gli altri sono tutti religiosi. Pura agiografia. Questo mi pare di scavo psicologico….Eh, forse è quello che ci voleva. Non era un tipo facile, Isabella Tomasi… Gli dissi che avevo scritto un libro su Hitler ed ero stato incoraggiato da un famoso prete di Palma. Cominciò a chiedermi in quale quartiere ero nato. Mi disse che lo conosceva, mi parlò della chiesa di Sant’Angelo, la seconda chiesa più antica di Palma, da cui prendono nome la piazza e il quartiere omonimo. Si dilungò sulla storia di questa piccola chiesa, sul suo piccolo convento, che volle fare costruire Isabella Tomasi. Perché quella era la parte più alta del paese ed era vicino al Palazzo Ducale poi diventato Monastero delle Benedettine.

Si parlò di Palma di Montechiaro, la Donnafugata del romanzo. Lui mi disse dei cattivi rapporti con i politici locali, delle oscenità architettoniche che si stavano realizzando, della pavimentazione del centro storico, delle statue. Stimava pochi palmesi, soprattutto il grande archeologo scomparso Giacomo Caputo. Prendemmo il discorso della politica, fu d’accordo con me sulla storia del Meridione, sulle nefandezze dei Savoia, sul revisionismo storico. In un momento della conversazione si dilungò sulle famiglie nobiliari siciliane. Strano, pensai, un nobile e un socialista d’accordo sulla storia. Guardava sempre negli occhi, ascoltava con attenzione e pazienza. Il professore, sfogliando continuamente il libro, si soffermò sul capitolo dedicato al suo padre adottivo. Ne profittai per dirgli quello che pensavo e che ho scritto sul romanzo.
Il Gattopardo non è propriamente un romanzo storico, esordii, piuttosto un romanzo intimistico-familiare. Questo ho pensato e questo ho scritto. Diciamo pure che è anche un romanzo storico, una storia vista dal punto di vista dei nobili Tomasi. In questo senso, non poteva che essere un romanzo conservatore, continuai, misurando le parole per evitare di offenderlo. Ma è alta letteratura, una scrittura lirica, classica, alta, bella, e l’opera letteraria viene giudicata solo dal punto di vista estetico. E pertanto Il Gattopardo è un grande libro, un capolavoro nel suo genere. Sì, disse il professore, ma non è un libro reazionario. Don Fabrizio, Tancredi, sono consapevoli del nuovo che avanza, del tempo del loro declino. È un libro legato all’inconscio, disse, al trauma infantile, per questo è sempre moderno. Sono d’accordo, dissi io, in fondo ogni scrittore, anche il più oggettivo, mette nel suo libro qualcosa che gli appartiene, qualcosa della propria infanzia.
Il finale del romanzo, il trionfo della morte e del sonno. Di una religiosità cupa. Presi il libro su Isabella Tomasi e lessi l’ultima pagina. “Giunta faccia a faccia con lui sollevò il velo e così, pudica ma pronta a essere posseduta, gli apparve più bella di come mai l’avesse intravista negli spazi stellari. Il fragore del mare si placò del tutto”, quasi recitai a memoria. Il professore annuiva. Continuai.
Così muore l’ultimo grande Principe nel Gattopardo. Solo Giuseppe Tomasi di Lampedusa poteva riscattare il declino, la rovina, il disfacimento di una famiglia, di una stirpe, di un tempo, di un’epoca. Così finisce, e trova il suo destino il Gattopardo, con una delle più alte pagine della letteratura europea. Con un’immagine misteriosa di bellezza e di perfezione, quella che il Principe in tutta la sua esistenza aveva cercato nel cielo stellato e nel tempo arcano dell’universo, chissà dove lo avrebbe portato, forse nella pace della sua stirpe e della sua storia.
Questo è il Gattopardo: un senso di disfacimento e di morte che percorre tutte le vicende del romanzo e s’insinua in tutti i meandri della sua storia. Della vostra storia. Morte è la solitudine scontrosa del Principe, che con moglie e sette figli ha creato il deserto nella sua famiglia e poi il vuoto nell’intera isola. Morte sono gli occhi di vetro di Bendicò, il vuoto interiore di Concetta alla fine, la vecchiaia di Angelica vedova, la rovina fisica delle tre figlie rimaste zitelle del principe Fabrizio, morte sono le manie senili del culto di false reliquie di santi mostrate al Monsignore, settantaquattro ne possedevano, ottusità superstiziosa della stirpe – come la religiosità superstiziosa, astorica, talvolta efferata, vissuta da tanti antenati a Palma -, sinfonia mortuaria, e sono fantasmi, simulacri, come in fondo larve ferme nel tempo sono quasi tutti i personaggi del Gattopardo. Che in un istante si disgregano.
La morte governa lo spazio e il tempo del Gattopardo. Dal puzzo del cadavere del soldato borbonico venuto a morire nel giardino del Principe, pure esso nel pieno rigoglio di simboli funebri, al paesaggio siciliano dell’estate visto come un deserto infernale o come devastazione fangosa nell’inverno, alle camere vuote, polverose e assenti, del palazzo di Donnafugata, ai morti ammazzati nelle trazzere, la morte accompagna le cose e gli eventi, vive con la sua memoria e il suo pensiero accanto a tutti i viventi, che sembrano ombre, spettri, fantasmi del passato, il Principe e la sua famiglia, e tutti gli altri.
Morte è il sentimento del perire della bellezza, lo stesso sentimento di morte che percorre sempre la mente di don Fabrizio, e che si ferma, si cristallizza nell’incubo sgomento dei cadaveri appesi per il collo e mummificati sui muri del cimitero dei Cappuccini di Palermo.
Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi, rassegnazione, fine della storia e del progresso. Ah, questa dimensione, quest’appartenenza a un destino comune di morte che è di tutta la letteratura siciliana! È un sentimento che percorre la letteratura siciliana post-garibaldina, dalla grandiosa, lugubre, elegia di morte che inonda le vicende de “I Viceré” di De Roberto – dove gli Uzeda si domandano che cosa dovranno fare per restare sempre a galla -, a Verga in tutta la sua opera, al Pirandello de “I vecchi e i giovani”, a Sciascia. Morte è il fondo desolato, erotico e fascista, dell’ispirazione di Brancati, morte è il rifugio nei moduli poetici e nella storia di Consolo, come uno scappare dalla storia. Anche nel Gattopardo vi è questo sentimento, scappare dalla storia. Il rifiuto della storia. Questa è la tragedia di don Fabrizio: l’estraneità alla storia, sentirsi uomo fuori dalla storia, la consapevolezza che dopo di lui c’è Calogero Sedara, come se questi non fosse egli stesso storia. Tutta la letteratura siciliana è una grande poesia di morte che però, purtroppo, non ha mai avuto il genio di un Gòngora.
Quella del Gattopardo è una decadenza familiare, economica, politica e sociale. È proprio questo che caratterizza il Gattopardo, il sentimento di disfacimento, di decadenza di una famiglia, di una classe sociale, di un’epoca. È un mondo che sta per sparire, e ne è consapevole Giuseppe Tomasi. Don Fabrizio, come del resto tutti gli altri della sua famiglia, impotente di fronte al dramma del disfacimento della sua stirpe e della sua classe sociale, è più attento alle cose del cielo che a quelle della terra. Lui, il ricco di famiglia, l’aristocratico dai possedimenti rarefatti rispetto a certe cartine, di terre che il Principe – come tutta la nobiltà siciliana che si era concentrata a Palermo e che aveva lasciato i vecchi castelli e le case di campagna agli amministratori, ai “collettori” e ai “gabelloti”, ai mezzadri – mai forse aveva visitato, ormai è il passato.
Il futuro è don Calogero Sedara, il borghese arricchito, il proprietario dei nuovi tempi, il ceto borghese-mafioso, dedito a ruberie e a usure esercitate sui padroni. Don Calogero, volgare, sguaiato, becero, che sale impacciato le scale, col suo frac sgangherato, “la rivoluzione borghese che saliva le sue scale”, disprezzato dall’aristocratico don Fabrizio. Il futuro sono la bellissima e sensuale Angelica, lo squattrinato Tancredi.

Il sonno, la morte. Giuseppe Tomasi descrive una Sicilia onirica, sognante, un paesaggio malinconico monotono, che sobbalzava “sotto la luce di cenere”, preda del cangiante dormiveglia, e questo scorrere immutabile diventa condizione umana, giudizio etico, una visione fascinosa che si tramuta in condanna storica. È un’atmosfera amara, disincantata, che si proietta su uomini e cose, su paesaggi ed eventi, ed è il segno di un disinganno assoluto, senza sogni e speranze, la sfiducia totale nella storia.
La morte nel Gattopardo è associata all’idea della vecchiaia e del sonno, al tramonto di una classe sociale, al patrimonio che si dissolve, alla dinastia che si estingue. Anche i ricordi parlano di morte, i personaggi sono incapaci di provare entusiasmo e gioia, la vita si trascina “senza costrutto, senza scopo”, senza emozioni. Il paesaggio – città, campagne, uomini, paesi – è avvolto da una cappa di nebbie funeree. Il paesaggio siciliano, così incantato, ha sempre questo doloroso senso di morte.
Oh, il paesaggio siciliano! No, il paesaggio siciliano è come l’anima siciliana, è il torporoso pomeriggio e la luce tremolante che abbarbaglia, che congiunge tutte le distanze, è la parvenza spettrale falba e la vastità chiara del mare e del cielo stellato, l’esuberanza e la follia dell’estate, la vaporosa caligine del crepuscolo. Fu quello, forse, che conobbe da bambina Isabella, quello che vedeva prima di entrare nel Monastero. Sì, la Sicilia è l’esasperata aristocratica solitudine e la rivoluzione delle moltitudini offese, la vita randagia dissipata, la canicola gloriosa che arde tremante sui campi, la Sicilia è allucinazione, visione, miraggio, abbaglio e illusione, svolazzante paesaggio del sogno, la Sicilia è la vita che ha l’esuberanza e la mistificante bellezza dei sogni.
Che belle parole, disse il professore. Molto vicine al vero. Il romanzo, al di là dei giudizi critici di ognuno, è comunque di una bellezza sconvolgente. Vittorini ha sbagliato a non pubblicarlo.
Sì, è così, dissi. Quante critiche vuote, professore, al Gattopardo. Lo consideravano conservatore, reazionario, poi, pian pianino, dopo che dalla Spagna e dall’estero cominciarono a giungere critiche positive, anche la sinistra italiana, soprattutto i comunisti, sdoganarono il libro. Anche Togliatti, anche Sciascia e altri intellettuali di sinistra. Già, disse il professore. L’ostacolo era che Tomasi parlava dell’inerzia delle classi dirigenti filoborboniche ma anche delle masse. Se consideriamo quel che hanno fatto le masse meridionali nel secolo passato e anche oggi, non mi pare che si sia sbagliato.
La segretaria con un sorriso gli mostrò l’orologio. C’era un altro impegno. Il professore chiuse gli occhi, annuì. Capimmo anche noi. Ci alzammo e lo salutammo dandogli la mano, lui rimase seduto. Ringraziò ancora per i libri e i biscotti ricci. Disse alla segretaria di farci visitare le stanze del palazzo. Alla fine, prima di uscire, prima dello scalone, vidi il quadro di Giulio IV, il Gattopardo. E il suo famoso cannocchiale. Si concentra tutta qui la storia dei Tomasi, dissi alla cortese segretaria, dai fondatori di Palma di Montechiaro allo scrittore. Pensarono più alle cose del cielo che a quelle della terra.