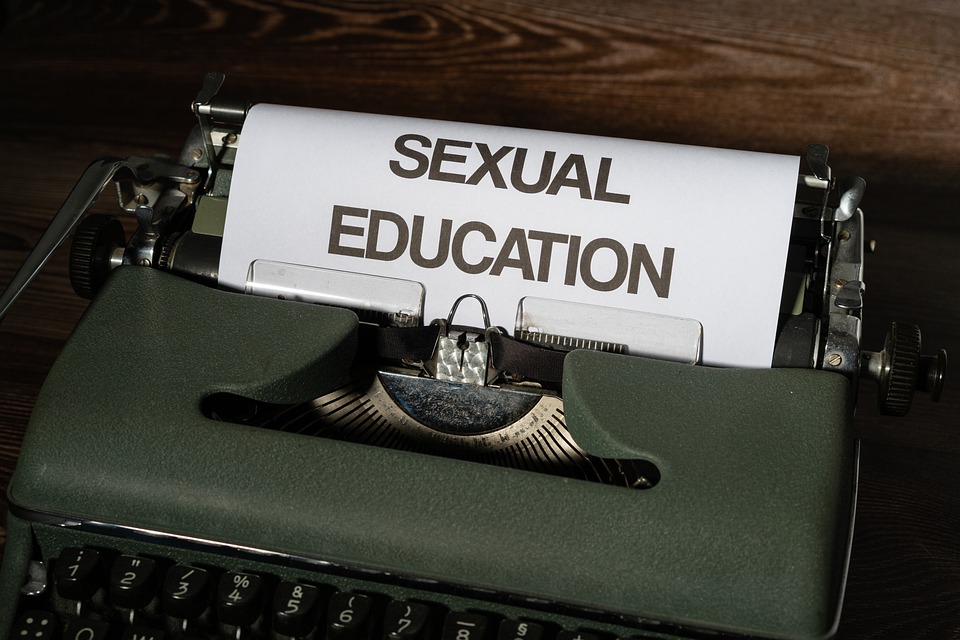Il terremoto dell’Irpinia e la vita post sisma
di Maria Luisa Donatiello
–
I LUOGHI DELLA MENTE OVVERO LE MIE MEMORIE
Il terremoto dell’Irpinia del 1980 si verificò il 23 novembre 1980 e colpì la Campania centrale e la Basilicata centro-settentrionale, con parte della provincia di Foggia entro il confine con le due regioni, coinvolgendo, però, in maniera molto ridotta anche tutto il resto dell’Italia meridionale. Caratterizzato da una magnitudo di 6.9 (X grado della scala Mercati) con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della Campania, causò circa 280 000 sfollati, 8 848 feriti e, secondo le stime più attendibili, 2 914 vittime.
Pubblichiamo le riflessioni di Maria Luisa Donatiello per riflettere sul post terremoto.
Quando nacqui mia madre mi chiamò Maria, pregò per me e mi affidò alla protezione della Vergine. È grazie a entrambe, mi piace pensare, che crebbi florida e serena e fra i tanti regali di cui Dio mi fece dono il più gradito fu la vista poiché l’osservazione fu necessaria alla conoscenza del mondo in cui vissi e della cui essenza mi appropriai tanto da maturare, negli anni della giovinezza, la convinzione, mai più abbandonata, che ciò di cui i miei occhi furono testimoni si chiamasse paradiso e che esso non sia soltanto la casa del Padre, bensì anche una condizione di vita e una realtà a cui un luogo terreno e una condizione dell’anima possono assomigliare.
Si dice che la bellezza sia un concetto relativo, eppure i luoghi della mia infanzia sono, senza dubbio, di uno straordinario splendore. In quei luoghi toccavo seriche foglie e ruvidi gusci di lumache. Mangiavo aspre amarene e dolci more dei grandi rovi selvatici. Calpestavo l’umido terreno all’interno del bosco, mai raggiunto dai raggi del sole, e l’arido fieno nelle stalle dei cavalli. Alle narici il vento fresco di montagna portava il penetrante odore di sterco delle mucche e delle pecore al pascolo e quello aspro dell’erba tagliata, quello dolce delle viole e delle rose. Le mie origini sono da ricercarsi in un piccolo paese dell’alta Irpinia in cui abbondavano, all’epoca della mia infanzia, cani, vedove e prefabbricati. Eppure, nonostante l’aspetto ingannevole del luogo, all’apparenza triste perché impoverito, ferito, colpito dal terremoto che lo rase al suolo il 23 novembre 1980, lì si sono consumati i più bei giochi di quando ero bambina, la mia infanzia felice tra boschi, serpenti velenosi e campi coltivati, tra le more e le fragole di bosco trovate per caso, private alla natura, mangiate per gioco.
La vita di paese seppe conquistarmi con la propria essenza, con la bellezza della genuinità e della vita autentica di cui soprattutto sono innamorata. Quel luogo fu per me l’occasione di libertà, di muovermi autonomamente per le strade e per la campagna che in città, da bambina, non avrei altrimenti avuto. Fu il contatto con la terra, con la natura, con la tradizione dei miei avi, rappresenta oggi le mie radici e quando vago per il mondo sono serena, conosco, su questa terra, dove posso sempre andare e sentirmi a casa. Soltanto lì, in nessun altro luogo terreno, prima della meta finale, posso davvero fare ritorno.
A tutti i miei compagni di giochi ero affezionata, ma con Luca e Gaia mi divertivo di più che con altri. Di Gaia non mi stancavo mai. Trascorsi con lei tutta la mia infanzia. Eravamo compagne di scuola e di giochi. Luca, un ragazzetto robusto, dai capelli neri e la carnagione olivastra, era un bambino gioioso che amava le avventure alla scoperta della natura. Nei pomeriggi estivi ci davamo appuntamento in contrada Vallone delle Tegole, ovvero in campagna, a casa mia. Nei dintorni della villa andavamo per sentieri lunghi ed erbosi, presso i corsi d’acqua che in qualche luogo, a noi non sempre visibile o noto, avevano origine, attraversavano in superficie parti di terreno solcandolo, alimentandolo. Nell’imbatterci nei rivoli e nell’attraversarli sporcavamo i nostri vestiti, consuetudine assai divertente. Correvamo tra i fiori di campo. Sudore e cadute, lividi e graffi facevano parte del gioco, li si metteva in conto. Ci sedevamo sul terreno o sull’erba a raccontare storie fantastiche e di paura della tradizione del luogo, storie di streghe e folletti dispettosi, di janare e lupi mannari. Da bambini respiravamo spensieratezza, infondevamo allegria anche negli altri. Nel bosco immaginavamo di ci inoltrarci per raggiungere il mondo incantato delle fate. Andavamo nel regno dell’elfo bianco, il genius loci che ci piaceva credere esistesse davvero e proprio lì, in quel luogo incontaminato, a pochi passi dalla villa. Fuggivamo dal mondo della razionalità percorrendo un sentiero ai cui lati, dal terreno, spesse radici di alberi secolari si mostravano ai nostri occhi con sembianze zoomorfe. Così vedevamo teste di leoni e di draghi come sculture lignee prodotte da un capriccio della natura e dalla nostra fantasia. Quel sentiero oggi rappresenta per me un luogo della mente giacché, ritornata nel bosco, più volte e in seguito al taglio degli alberi, non sono mai più riuscita a ritrovarlo.
Un dato di fatto fu l’assenza di morti nella mia famiglia in quella disastrosa domenica di novembre, mentre altri a causa del terremoto persero i propri cari. Mariti, mogli, genitori, fratelli, figli seppelliti sotto le macerie delle proprie case. A quei tempi io non ero ancora nata. Non vidi mai, non feci in tempo a nascere, la casa dei miei nonni, quella in cui mia madre visse da bambina. Dai racconti di mio nonno, dalle fotografie in bianco e nero, ormai ingiallite dal tempo, ritrovate sotto le macerie e custodite da lui gelosamente, ho potuto ricostruirne la storia e l’aspetto supportata dalla fantasia, attitudine che consente di esaltare cose, eventi e persone rivestendoli di nuovi luci e colori, asseconda i desideri, confonde la vista, distoglie dal vero, tanto che un ammasso di pietre secolari ha assunto nella mia immaginazione un aspetto favoloso scaturito dall’impossibilità di conoscere, di vivere quei luoghi e in tal modo di ridimensionarli. È la lontananza fisica o temporale la causa della malinconia e dell’esaltazione della realtà che fu. L’abitazione era denominata Palazzo Rubini dal nome della famiglia di nobili dalla quale il mio bisnonno l’acquistò nel 1943. Un palazzo settecentesco di quaranta stanze che venne rimpianto dai miei nonni per tutta la vita poiché nessuna casa costruita e abitata in seguito poté eguagliarlo in imponenza e splendore. A causa del sisma il palazzo venne raso al suolo completamente. Sul grande terrazzo, che era stato luogo di feste, cadde, distruggendo tutto, il campanile della Chiesa Madre situata di fronte al palazzo in via Monte. Dopo il terremoto i miei nonni vissero per vent’anni in un prefabbricato di due stanze, eppure, a sentirne i discorsi, pare che l’amarezza, conseguenza dell’evento, non turbò quegli anni gioiosi che essi vissero tra lauree e matrimoni di figli, nascite di nipoti, continuando a condurre la vita di sempre tra lavori in campagna, uncinetto e lettura della Bibbia.
Durante il periodo della ricostruzione da una casa distrutta ne sorse un’altra. La mia fu costruita in campagna, in terreni che già prima del terremoto erano stati di proprietà della mia famiglia. La villa sorse appena fuori paese, ma più in alto, su in collina, tanto da sovrastare Teora e vederla nella sua complessità. Di notte l’abitazione sembrava un faro interamente illuminata dai lampioni del giardino, dalle luci del terrazzo e del grande portone d’ingresso, tanto da indurre chiunque si trovasse giù in paese ad alzare lo sguardo in direzione di quella unica luce proveniente, come se da essi fosse emessa, dalla collina e dai boschi. Giardini e aiuole circondavano la casa insieme all’orto, al vigneto, al bosco situato sull’estremità della collina e al prato rigoglioso e ricco di fiori di campo tra i quali correre a perdifiato. Risalendo l’unica strada che conduceva alla villa se ne poteva scorgere soltanto il tetto, il resto veniva coperto alla vista da alti cespugli di more, dagli alberi cresciuti ai margini del viale asfaltato, dai pini decennali che circondavano il giardino insieme alla siepe di lauro dalla forma geometrica, rigida conferitale dalla potatura annuale. Vivevo con mia madre e con mio padre. I nonni abitavano giù in paese, ma trascorrevano con noi la maggior parte del proprio tempo dedicandosi alla cura dell’orto e del vigneto. È la terra di Teora a custodire oggi i loro corpi.
Tutto l’arredamento della villa era in legno di castagno, il ché infondeva, in chiunque ne vivesse gli ambienti, un senso di protezione e di accogliente tepore. Nelle domeniche d’inverno, come personaggi di un presepe, di un sereno quadretto di vita familiare, ci riunivamo nel salone della villa. Un orologio a pendolo era stato inchiodato da mio padre alla parete della canna fumaria. I suoi ticchettii e rintocchi scandirono il tempo di quegli anni felici. Sedevamo sul divano in tessuto rosso disposto a semicerchio di fronte al camino in pietra viva che custodiva due grossi e infuocati ceppi di quercia. La legna arsa riscaldava e illuminava l’ambiente. A Teora, d’inverno, la neve era una costante. Ne cadeva per giorni accumulandosi. In quelle circostanze la campagna assumeva le sembianze di un presepe vivente. Case basse, finestre illuminate, alberi sparsi e diradati e quando il vento aleggiava sui tetti innevati, la notte li avvolgeva, il fumo dei camini accesi imbiancava l’aria e sovrastava dolce e malinconico il silenzio era Natale, anche se non era dicembre, anche se non si festeggiava nulla. Le castagne arrostivano sulla brace. Le patate e le pigne venivano cotte sotto la cenere. L’atmosfera era tipicamente natalizia. Quando di domenica mattina i miei nonni tardavano a raggiungerci in campagna ero io che nei giorni assolati mi incamminavo verso il prefabbricato. Aggirandomi per il paese osservavo con curiosità e diffidenza, e senza al principio comprenderne il senso, le lunghe vesti nere che coprivano i corpi gracili delle vedove. Venivano indossate quotidianamente allo scopo di mantenere viva la memoria del lutto. Una donna ricordo fra tutte con più affetto. Angelina era il suo nome. Abitava nella fila di prefabbricati in cui abitavano i miei nonni. Trascorreva intere giornate a prendersi cura di un metro quadrato di aiuola posta davanti all’ingresso della propria casa. Qualche buon uomo aveva recintato quello spazio per evitare che le piante crescendo ostruissero il passaggio lungo il vialetto che collegava le abitazioni. In quel recinto erano cresciuti fiori del colore della pazienza, dell’accettazione, della rassegnazione: rose e margherite candide. La povera Angelina era rimasta sola, vedova e senza figli. La sua unica creatura di appena sei anni le fu portata via dal sisma, da quell’immensa tragedia umana avvenuta una domenica di novembre che se fosse trascorsa oziosa, tanto da poter essere dimenticata da tutti coloro che la vissero, avrebbe giovato a molti. Era tanto buona Angelina. La tragedia non era riuscita a incattivirla. Quando ci incontravamo mi rivolgeva uno sguardo materno, un sorriso affettuoso, con fare di complicità mi diceva – Aspetta. – e io già capivo, mi voltava le spalle ed entrava in casa. Nell’attesa che tornasse rimanevo fuori a guardarne l’interno. Scorgevo, ubicato in un angolo, un altarino illuminato da candele e lumini, sul quale corone di fiori freschi incorniciavano una foto del bambino defunto e tutt’intorno, tappezzate di foto annerite, consunte e antiche le pareti della casa costituivano il suo privato archivio della memoria. Ritornando da me stringeva tra le mani cioccolata e caramelle. Accettavo i doni, ringraziavo e mi congedavo con un sorriso. Poi con una corsa raggiungevo la porta d’ingresso di casa dei miei nonni. Li salutavo con due baci e mi dirigevo in cucina alla ricerca del pan di spagna al cioccolato preparato da nonna qualche ora prima. Lo vedevo in bella mostra, nella credenza, su un vassoio.
Aprivo l’anta di vetro e mi inebriavo dell’odore vanigliato che emanava. La vista e il profumo del dolce, alto diversi centimetri, ricoperto di zucchero a velo e farcito con crema al cacao, addolcivano gli animi e l’aria che si respirava. Il prefabbricato dei miei nonni era l’ultimo di una fila di quattro. La finestra della camera da letto volgeva sull’ingresso della piccola chiesa di legno del paese alle cui spalle si ergeva un alto campanile. Di domenica mattina le campane suonavano per richiamare i fedeli e per la vicinanza della casa al luogo sacro le sentivamo più intensamente che in qualunque altro punto del paese. Io e nonna andavamo a messa e come noi facevano in molti per preservare, nonostante tutto, dignità e fede. Il mondo che conobbi nei primi anni della mia vita costituisce oggi un luogo della mente in cui ho confinato i migliori ricordi e a cui faccio ritorno ogni volta che lo desidero. I luoghi della mente sono reali quanto ciò che si percepisce attraverso i sensi. Sono, più che mai, tangibili, vivi ed esistono.
A incrementare il numero dei compagni, in estate e nel periodo natalizio, giungevano altri bambini dal Nord Italia, dalla Svizzera e qualcuno, non tutti gli anni, dagli Stati Uniti, dall’Argentina, dal Brasile. Erano figli di emigranti. Allora ci si incontrava nella piazza del paese e si giocava tutti insieme. Che da tali incontri, i cui partecipanti furono in principio uniti soltanto dalla devozione al gioco, siano sorti in seguito amori e amicizie fraterne, questo è ciò che riguarda un periodo più tardo della nostra esistenza. Sorgeva nel paese di legno, di stradine e vicoli, di aria fresca e salubre, l’edificio della scuola dell’infanzia che molti di noi avevano frequentato. Era il luogo prediletto da noi bambini per la sua grande attrattiva: le giostre. Scivoli e altalene erano custodite in un giardino recintato che circondava il prefabbricato per tre lati. L’accesso ai balocchi non risultava impresa facile, ma riuscivamo a ottenerlo sempre scavalcando un alto cancello di legno, facendo forza sulle braccia e affidamento sull’agilità delle gambe. I più alti e robusti offrivano aiuto ai più minuti. Sull’altalena sedevamo noi bambine. I maschi preferivano gli scivoli e una palla di ferro su cui arrampicarsi. Sull’altalena il vento mi accarezzava il volto e smuoveva i capelli, io volgevo lo sguardo al cielo ed ero felice. Giocavamo fino al tramonto poi ci dirigevamo nuovamente verso il cancello di legno per uscire dal recinto. Quando scendeva la sera io, Gaia e Luca ci incamminavamo verso casa percorrendo una stradina ai cui lati si mostravano a noi le belle di notte, al culmine della fioritura e dello splendore, nella varietà di colori e sfumature. Le coglievamo per goderne del profumo dolcissimo o per farne ornamento per capelli mentre rincasavamo per lavarci, cenare e tornare a bighellonare in strada. Ovunque stessimo noi bambini, poco distante, su un muretto o una panchina, sedeva Gerardo da noi detto il pazzo. Viveva rifugiato in un soliloquio (vaniloquio!) quotidiano. Ormai vecchio e claudicante lasciava che il peso del proprio corpo venisse sorretto a ogni passo da un robusto bastone di legno. La lentezza nel camminare veniva compensata dalla rapidità con la quale pronunciava parole di cui non comprendevamo il senso. Ci osservava per ore, ma se correndo ci capitava di avvicinarci troppo a lui, sollevava il bastone e urlava suoni minacciosi. Era innocuo, ma a me faceva paura e tristezza. Lo turbava la nostra esuberanza, eppure la contemplava. A noi turbava la sua solitudine, ma quando morì al funerale piangevamo tutti. Ci accorgemmo che la sua presenza ci era stata cara. In seguito ci mancò e col tempo, ripensando a Gerardo, ho imparato a non temere ciò che non conosco. Oggi so che la diversità è soltanto una variazione su tema. Perciò, come accade per le persone che contano, che lasciano il segno nella vita degli altri, a distanza di anni ne ricordo ancora il volto e il nome.
Come lo scorrere del fiume viene frenato, deviato dai massi che sporgono dal suo letto così un intoppo, un ostacolo postomi lungo il cammino, mutò il corso della mia vita. Quando il vero amore si manifestò avevo da qualche giorno raggiunto la maggiore età. Ho sempre creduto che mio marito sia stato un dono di Dio, che mi fosse stato assegnato perché compensasse uno squilibrio. Lui è la parte migliore di me che fino a quel momento mi era mancata. Qualcuno lo condusse in paese perché lo incontrassi, di questo ne sono certa. Aveva ventitré anni quando lo conobbi. Fu una visione estasiante. Era di una bellezza, di un magnetismo, di un fascino che non si erano ancora visti da quelle parti. Mi fu presentato una sera e parlammo per ore. Ci lasciammo con l’intenzione di rivederci presto. Trascorremmo insieme tutto il giorno seguente. Gli feci conoscere la mia terra, i miei boschi, il mio mondo. Stavo bene con lui, era come se lo conoscessi da sempre. Il terzo giorno mi baciò. Le nostre labbra si unirono, poi mi guardò, mi sorrise e mi accarezzò il viso. Aveva gli occhi lustri come di chi ha cercato qualcosa che sembrava non esistere, non potergli essere concessa, di chi l’ha cercata nel vagare, negli sguardi altrui, nei sogni, finché un giorno la trova inaspettata. I miei occhi guardavano l’altra metà di me, la parte mancante che compensa e perciò la più importante. Rimase a Teora per l’intera estate poi ripartì e io con lui. Venne così il giorno in cui abbandonai i luoghi della mia infanzia per raggiungerne altri dettati non più dalle radici, dalla spensieratezza e dal gioco, ma dall’amore che giunge sempre irruento, inaspettato, si impose nella mia vita con dolce e gradita prepotenza e con esso l’età adulta. Dopo la mia partenza la villa fu venduta e la ricostruzione del paese completata in trent’anni. Sono tornata a Teora non più bambina. Soffermandomi a osservare vicoli, case, ho lasciato che i ricordi sopraggiungessero a fermare il tempo, l’avanzare dei miei passi. Folate di vento hanno spettinato i miei ricci come per distogliermi dall’osservazione, come a dirmi prosegui, non soffermarti, non rivangare. A ogni passo mi sono accorta che il paese, mutato in parte nella forma, ha conservata inalterata la propria essenza. Le nuove costruzioni, sebbene abbiano cancellato le tracce dei vecchi prefabbricati, non sono riuscite a intaccare l’odore dell’aria, l’atmosfera teorese. Ho incontrato Gaia e Luca e appreso che si sono sposati, che Angelina ha raggiunto il figlio in cielo, che la tomba di Gerardo è sempre adorna di fiori, che al posto delle giostre oggi sorge un palazzo, che la chiesa è stata ubicata altrove in un edificio nuovo e più grande. Poi mi sono incamminata verso casa. Ritornando alla villa ho sentito crescere in me il timore della sofferenza. Ho creduto che la sua vista mi potesse suscitare quel sentimento di afflizione, doloroso, quella mestizia che l’uomo è solito chiamare nostalgia e alla quale sono spesso incline. Della casa ho scorso dapprima il tetto e un fremito mi ha pervasa, ma quando sono giunta in cima alla salita si è mostrata a me rinnovata in forme e colori, abitata da nuovi inquilini, scoperto che lo stato delle cose né mi turba, né mi dispiace. Attraverso gli occhi della memoria in ogni luogo mi sono rivista bambina tanto da rimproverare a me stessa l’aver peccato di ingenuità. Perché mai ho creduto che un mattone in più o in meno, di proprietà mia o altrui, avrebbe potuto mutare le cose? Mi sono convinta ormai che la villa chiunque può abitarla, giacché al momento della mia partenza e della sua vendita tutto è già stato conquistato, posseduto, custodito e immutato nel ricordo vive.