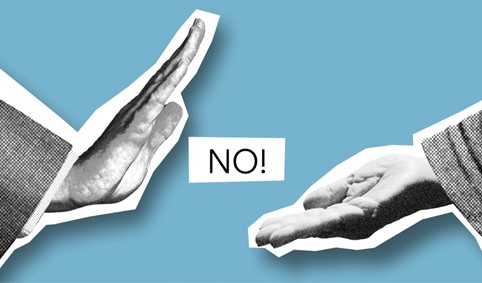Arriva “Il Gattopardo” targato Netflix (speriamo che non tradiscano il testo!)
di Francesco Bellanti
–
PUBBLICHIAMO IN DUE PARTI UN BREVE SAGGIO DEL PROFESSORE FRANCESCO BELLANTI SUL GATTOPARDO DI GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, MENTRE È IN PROGETTO UNA SERIE IN SEI EPISODI PER NETFLIX CON UN CAST DI GRANDI ATTORI DOPO IL CAPOLAVORO DI LUCHINO VISCONTI DEL 1963.
Parte prima: Il SONNO E LA MORTE
Declino, rovina e disfacimento nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, storia e critica di un grande libro che però ha anche dato un’immagine sbagliata della Sicilia.
Nella sterminata letteratura scritta sul Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa – romanzo di cui tutti parlano ma quasi nessuno legge – , frutto principalmente dell’interesse suscitato dall’eco mondiale del film, anche queste brevi note dell’umile professore di provincia possono trovare posto, soprattutto perché espressione di una più che trentennale – talvolta tediosa – frequentazione didattica del libro, intorno al quale chi scrive ha tastato il polso a generazioni di studenti e di fior di critici letterari. Diciamo che sono, queste brevi note, espressione di un debito professionale più che di un reale interesse per un libro che – e cercherò di dimostrarlo – che però ha anche dato un’immagine sbagliata della Sicilia. Il giudizio critico sul libro chi scrive lo aveva già sigillato durante il periodo universitario, quando lo lesse per la seconda volta – la prima era stata al liceo – e mai avrebbe immaginato che ne avrebbe parlato dopo trentacinque anni e decine di riletture.
Prima di ripercorrere – cosa senz’altro non agevole – la vicenda piuttosto complessa della pubblicazione del romanzo, peraltro raccontata più volte dal figlio adottivo Gioacchino Lanza Tomasi e dai testimoni dell’epoca, entriamo subito nella storia e nei significati più profondi del Gattopardo.
“Nunc et in hora mortis nostrae. Amen”. Con queste parole comincia il Gattopardo, e con altre di morte si chiude, “poi tutto trovò pace in un mucchietto di polvere livida”, a definire il destino del corpo imbalsamato di Bendicò, irrisione e metafora di un’epoca più che ricordo del padrone, scaraventato fuori da una finestra di palazzo Salina e gettato nel cortile, fra le immondizie. Lo stesso Tomasi di Lampedusa, in una lettera al barone Enrico Merlo di Tagliavia del 30 maggio 1957, quasi due mesi prima della sua morte a Roma per un cancro ai polmoni, indicava, a mio avviso, la chiave di lettura del romanzo. In una lettera testamento percorsa dal sentimento della fine imminente, Tomasi di Lampedusa diceva all’amico di avere scritto un’opera nella quale intendeva narrare la storia del decadimento della sua famiglia fino al quasi totale disfacimento, “con una certa compartecipazione dell’autore e senza nessun astio, come si trova invece nei Viceré”. In questa lettera, oltre a confermare che la Donnafugata del romanzo è Palma di Montechiaro, lo scrittore parla di “malinconica poeticità” che muove le vicende del romanzo e dell’importanza che in esso hanno la “quistione delle reliquie che mette il suggello su tutto”, Bendicò, “il cane Bendicò è un personaggio importantissimo ed è quasi la chiave del romanzo”, e la morte di don Fabrizio.
Don Fabrizio. Pensò a tutta la sua vita, il Principe, prima di morire, cercando di coglierne il senso, di raggranellare fuori dall’immenso mucchio di cenere del nulla i pochi momenti felici: “Ho settantatré anni, all’ingrosso ne avrò vissuto, veramente vissuto un totale di due… tre al massimo”. E i dolori, la noia, quanto erano stati? Inutile sforzarsi a contare: tutto il resto: settant’anni. Doveva avere avuto un’altra sincope perché si accorse a un tratto di essere disteso sul letto. Qualcuno gli teneva il polso: dalla finestra il riflesso spietato del mare lo accecava… Fra il gruppetto ad un tratto si fece largo una giovane signora: snella, con un vestito marrone da viaggio ad ampia tournure, con un cappellino di paglia ornato da un velo che non riusciva a nascondere la maliziosa avvenenza del volto. Insinuava una manina inguantata di camoscio fra un gomito e l’altro dei piangenti, si scusava, si avvicinava. Era lei la creatura bramata da sempre che veniva a prenderlo; strano che così giovane com’era si fosse arresa a lui; l’ora della partenza doveva essere vicina. Giunta faccia a faccia con lui sollevò il velo e così, pudica ma pronta ad essere posseduta, gli apparve più bella di come mai l’avesse intravista negli spazi stellari.
Il fragore del mare si placò del tutto”.
Così si conclude, in sostanza, e trova il suo destino il Gattopardo, con una delle più alte pagine della letteratura europea. Con un’immagine misteriosa di bellezza e di perfezione, quella che il Principe in tutta la sua esistenza aveva cercato nel cielo stellato e nel tempo arcano dell’universo, chissà dove lo avrebbe portato, forse nella pace della sua stirpe e della sua storia.
La principale chiave di lettura del Gattopardo è proprio in questo senso di disfacimento e di morte che percorre tutte le vicende del romanzo e si insinua in tutti i meandri della sua storia. Morte è la solitudine scontrosa del Principe – che è poi quella dello scrittore – che con moglie e sette figli ha creato il deserto nella sua famiglia e poi il vuoto nell’intera isola; morte sono gli occhi di vetro di Bendicò, il vuoto interiore di Concetta alla fine, la vecchiaia di Angelica vedova, la rovina fisica delle tre figlie rimaste zitelle del principe Fabrizio, morte sono le manie senili del culto di false reliquie di santi mostrate al Monsignore, settantaquattro ne possedevano, ottusità superstiziosa della stirpe – come la religiosità superstiziosa, astorica, talvolta efferata, vissuta da tanti antenati a Palma -, sinfonia mortuaria, e sono fantasmi, simulacri, come in fondo larve ferme nel tempo sono quasi tutti i personaggi del Gattopardo. Che in un istante si disgregano.
La morte governa lo spazio e il tempo del Gattopardo. Dal puzzo del cadavere del soldato borbonico venuto a morire nel giardino del Principe, pure esso nel pieno rigoglio di simboli funebri, al paesaggio siciliano dell’estate visto come un deserto infernale o come devastazione fangosa nell’inverno, alle camere vuote, polverose e assenti, del palazzo di Donnafugata, ai morti ammazzati nelle trazzere, la morte accompagna le cose e gli eventi, vive con la sua memoria e il suo pensiero accanto a tutti i viventi, che sembrano ombre, spettri, fantasmi del passato, il Principe e la sua famiglia, e tutti gli altri. Morte è il sentimento del perire della bellezza, lo stesso sentimento di morte che percorre sempre la mente di don Fabrizio, e che si ferma, si cristallizza nell’incubo sgomento dei cadaveri appesi per il collo e mummificati sui muri del cimitero dei Cappuccini di Palermo.
Sulla scia della rassegnazione e del trasformismo gattopardesco, se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi, dice il nipote del Principe, che è il prendere atto dell’evoluzione storica e cercare di sfruttarla il meglio possibile, questa dimensione, questa appartenenza a un destino comune di morte è di tutta la letteratura siciliana. È un sentimento che percorre la letteratura siciliana post-garibaldina, dalla grandiosa, lugubre, elegia di morte che inonda le vicende de “I Viceré” di De Roberto – dove gli Uzeda si domandano che cosa dovranno fare per restare sempre a galla -, a Verga in tutta la sua opera, al Pirandello de “I vecchi e i giovani”, dove il principe don Ippolito Laurentano, alla notizia dello sbarco di Garibaldi, si rintana nel suo feudo e si crea grottescamente una forza militare composta di ex borbonici per difenderlo, mettendo a capo di essi un ex graduato borbonico e in questo modo cercando di evitare l’onda della storia. Morte è il fondo desolato, erotico e fascista, dell’ispirazione di Brancati, morte è il rifugio nei moduli poetici e nella storia di Consolo, come uno scappare dalla storia. Scappare dalla storia. Anche nel Gattopardo vi è questo sentimento, scappare dalla storia. Il rifiuto della storia. Questa è la tragedia di don Fabrizio: l’estraneità alla storia, sentirsi uomo fuori dalla storia, la consapevolezza che dopo di lui c’è Calogero Sedara, come se questi non fosse egli stesso storia.
Tutta la letteratura siciliana è una grande poesia di morte che però, purtroppo, non ha mai avuto il genio di un Gòngora.
La decadenza di una famiglia, che è morale e fisica ne “I Viceré”, è economica, politica e sociale nel Gattopardo. È proprio questo che caratterizza il Gattopardo, il sentimento di disfacimento, di decadenza di una famiglia, di una classe sociale, di un’epoca. È un mondo che sta per sparire, e ne era consapevole lo stesso Tomasi, che in una delle ultime lettere affermava:
“Mi sembra che [il romanzo] presenti un certo interesse perché mostra un nobile siciliano in un momento di crisi (che non è detto sia soltanto quella del 1860), come egli vi reagisca e come vada accentuandosi il decadimento della famiglia sino al quasi totale disfacimento; tutto questo però visto dal di dentro, con una certa compartecipazione dell’autore e senza nessun astio, come si trova invece nei Viceré”.
Don Fabrizio, come del resto tutti gli altri della sua famiglia, impotente di fronte al dramma del disfacimento della sua stirpe e della sua classe sociale, è più attento alle cose del cielo che a quelle della terra. Lui, il ricco di famiglia, l’aristocratico dai possedimenti rarefatti rispetto a certe cartine, di terre che il Principe – come tutta la nobiltà siciliana che si era concentrata a Palermo e che aveva lasciato i vecchi castelli e le case di campagna agli amministratori, ai “collettori” e ai “gabelloti”, ai mezzadri – mai forse aveva visitato, ormai è il passato. Il futuro è don Calogero Sedara, il borghese arricchito, il proprietario dei nuovi tempi, il ceto borghese-mafioso, dedito a ruberie e a usure esercitate sui padroni. Don Calogero, volgare, sguaiato, becero, che sale impacciato le scale, col suo frac sgangherato, “la rivoluzione borghese che saliva le sue scale”, disprezzato dall’aristocratico don Fabrizio. Il futuro sono la bellissima e sensuale Angelica, lo squattrinato Tancredi.
Il sonno, la morte. Tomasi descrive una Sicilia onirica, sognante, un paesaggio malinconico monotono, che sobbalzava “sotto la luce di cenere”, preda del cangiante dormiveglia, e questo scorrere immutabile diventa condizione umana, giudizio etico, una visione fascinosa che si tramuta in condanna storica. È un’atmosfera amara, disincantata, che si proietta su uomini e cose, su paesaggi ed eventi, ed è il segno di un disinganno assoluto, senza sogni e speranze, la sfiducia totale nella storia.
La morte nel Gattopardo viene associata all’idea della vecchiaia e del sonno, al tramonto di una classe sociale, al patrimonio che si dissolve, alla dinastia che si estingue. Anche i ricordi parlano di morte, i personaggi sono incapaci di provare entusiasmo e gioia, la vita si trascina “senza costrutto, senza scopo”, senza emozioni. Il paesaggio – città, campagne, uomini paesi – è avvolto da una cappa di nebbie funeree. Il paesaggio siciliano, così incantato, ha sempre questo doloroso senso di morte. Oh, il paesaggio siciliano! No, il paesaggio siciliano è come l’anima siciliana, è il torporoso pomeriggio e la luce tremolante che abbarbaglia, che congiunge tutte le distanze, è la parvenza spettrale falba e la vastità chiara del mare e del cielo stellato, l’esuberanza e la follia dell’estate, la vaporosa caligine del crepuscolo. La Sicilia è l’esasperata aristocratica solitudine e la rivoluzione delle moltitudini offese, la vita randagia dissipata, la canicola gloriosa che arde tremante sui campi, la Sicilia è allucinazione, visione, miraggio, abbaglio e illusione, svolazzante paesaggio del sogno, la Sicilia è la vita che ha l’esuberanza e la mistificante bellezza dei sogni.
La Sicilia è il tempo in cui tutto può accadere, è la sfuggente immagine del meriggio caldo, l’opulenta nullità della tarda primavera, la visionaria grandezza, la metafisica esistenza del vuoto. La Sicilia è il tempo sospeso e mai vuoto, l’annichilimento e la rinascita, la nostalgia, la melanconia, il sentimento della materialità e dell’infinito della terra, il labirintico ma sicuro cammino verso il progresso, questo il terrificante splendore della terra di Sicilia.
“L’Italia senza la Sicilia non lascia nessuna immaginazione nello spirito. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto”. Sono parole di Wolfgang Goethe, che colse molte di queste impressioni. Quelle che Giuseppe Tomasi di Lampedusa non ha colto o non ha voluto cogliere.
Anche la lunga scena del ballo è una sinfonia di morte, con quel sentimento penoso di continuare per altre tre ore, fino alle sei del mattino, per non fare intendere che la festa non era riuscita. Volti stravolti, la luce fumosa delle candele dei lampadari, “di mal’augurio”. Fuori era l’immondizia sui carri, il barroccio coi buoi uccisi verso il macello che esibivano le loro parti intime con l’impudicizia della morte. E don Fabrizio, che tornava a casa a piedi e guardava le stelle per trovarvi conforto, le stelle, così lontane, onnipotenti ma docili, proprio il contrario degli uomini. E la Sicilia?
Oh, la Sicilia! La Sicilia del non fare, la Sicilia vecchia, vecchissima, di magnifiche civiltà eterogenee, questo dice il Principe nel famoso colloquio con Chevalley, tutte venute da fuori già complete e perfezionate, nessuna germogliata da noi stessi, noi che da duemila cinquecento anni siamo colonia… Oh, la Sicilia! Questa centenaria trasportata in carrozzella alla Esposizione Universale di Londra, che non comprende nulla, che s’impipa di tutto… che agogna soltanto di ritrovare il proprio dormiveglia fra i suoi cuscini sbavati e il suo orinale sotto il letto… Il sonno… il sonno è ciò che i Siciliani vogliono, ed essi odieranno sempre chi li vorrà svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali… Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni oniriche, anche le più violente: la nostra sensualità è desiderio di oblio, le schioppettate e le coltellate nostre, desiderio di morte; desiderio di immobilità voluttuosa, cioè ancora di morte, la nostra pigrizia, i nostri sorbetti di scorsonera o di cannella; il nostro aspetto meditativo è quello del nulla che voglia scrutare gli enigmi del nirvana. … I Siciliani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione che credono di essere perfetti: la loro vanità è più forte della loro miseria; ogni intromissione di estranei sia per origine sia anche, se si tratti di Siciliani, per indipendenza di spirito, sconvolge il loro vaneggiare di raggiunta compiutezza, rischia di turbare la loro compiaciuta attesa del nulla…
Metafora di un tempo in cui il crollo di ogni ideologia si nutre di sonno e di morte, di violenza delle passioni più che di amore e di compassione, e diventa un cosmico destino. È il destino che si contempla quando si fugge dal terrore della storia. Questa è la Sicilia per il Principe. Il colloquio tra il Principe e il cavaliere Chevalley rivela la condizione disperata di un uomo, di una classe sociale, ma non di un intero popolo. Questa non è la verità sulla Sicilia. È la visione del mondo, il tormento, la condizione umana di una classe sociale, l’aristocrazia filoborbonica, che, con questa condanna ideologica, questo giudizio sull’immobilismo atavico dei siciliani, vuole trovare un alibi per la sua nefasta azione politica e sociale, per le sue gravi responsabilità storiche. Questa non è la verità sulla Sicilia. Questa è la Sicilia di una classe sociale che ha dato un sostanzioso contributo alla decadenza del tempo, una classe sociale, la nobiltà siciliana, che non ha mai cambiato il tempo ma il tempo lo ha lasciato così com’è, una classe sociale, la nobiltà filoborbonica, che – diversamente da Proudhon e dall’“ebreuccio tedesco” – non ha mai contato nulla nella storia d’Europa.
No, non è questa la Sicilia. La Sicilia del Principe, la Sicilia di Tomasi non è la vera Sicilia. La Sicilia non è quella del paesaggio infernale descritta nel romanzo, del voluttuoso vaneggiare, è, la Sicilia, il paradiso sognato dai Greci, dai Romani, dai Germani, dagli Arabi, da tutti i popoli del mondo, il giardino d’Europa, il profumo delle arance, la Sicilia di tutti i profumi, del sole, del mare, della terra e del fuoco. Terra delle viti in fiore, di ulivi contorti maestosi, terra dei cedri e dei limoni, del profumo delle albicocche e delle pesche mature, di zàgara, delle palme e dei fichidindia, delle rose e dei giardini: la Sicilia è la stordente bellezza di un paesaggio, di uno spazio e di un tempo in cui tutto può accadere.
La Sicilia è la terra dei grandi imperatori e delle civiltà superbe, terra di santi e di poeti, di scienziati eccelsi e di filosofi, terra di scrittori e di legislatori, la Sicilia di Archimede, Empedocle, Gorgia, Majorana, Antonello da Messina, Scarlatti, Bellini, Ruggero II, Federico II, della Scuola poetica siciliana, di Pirandello, Quasimodo, Verga, Capuana, De Roberto, Sciascia, Brancati, Vittorini, Guttuso, Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Crispi, Angelo Musco, don Luigi Sturzo, Giovanni Gentile, Pitrè, Buttitta, Tempio e di tanti altri. Questa è la Sicilia, incrocio di popoli fecondi, di culture profonde, terra di tolleranza. La Sicilia amata da Goethe, Idrisi, Guy de Maupassant, Stendhal, Dante, Tucidide, Plutarco, Pascoli, Carducci, certo odiata da altri, la Sicilia misteriosa e arcana, dai mille volti senza tempo.
Per queste ragioni, quelle stesse di chi vede nella morte non la fine delle cose ma il significato profondo e vero dell’essenza di tutte le cose stesse, le stesse ragioni che forse non dovettero percorrere la mente di don Fabrizio quando – ricordando la storia sua e della sua stirpe – da una stanza d’albergo guardava il mare che gli rappresentava l’infinito, il Gattopardo è un romanzo sopravvalutato, fuori dalle ragioni vitali del tempo – il tempo di Sicilia – che ha fatto tanto male e fa ancora male a questo paese e a questa terra. Narra un mondo fermo, dove c’è solo la morte, dove non c’è mutamento, che è la legge stessa della storia, anche la legge della storia di Sicilia.
Ma questo è un giudizio ideologico, il giudizio estetico è un altro, è quello stesso che ci fa giudicare, per esempio, l’opera di Verga conservatrice e quasi reazionaria nell’ideologia, ma formidabile e grande sul piano estetico, superiore a tutte le altre nella letteratura italiana, anche a quella di Manzoni.