Lo smarrimento del senso del peccato ed i suoi effetti
Di Sara Deodati
–
IL 2 DICEMBRE DEL 1984 SAN GIOVANNI PAOLO II PUBBLICAVA L’ESORTAZIONE APOSTOLICA “RECONCILIATIO ET PAENITENTIA” CHE, AL N. 17, DEFINIVA LA “GRAVITÀ” DEL PECCATO «UNA QUESTIONE INEVITABILE, ALLA QUALE LA COSCIENZA CRISTIANA NON HA MAI RINUNCIATO A DARE UNA RISPOSTA». NE RIPROPONIAMO L’INSEGNAMENTO FOCALIZZANDO LA PREZIOSA SUDDIVISIONE CHE PAPA WOJTYLA OPERA TRA PECCATI “VENIALI” E “MORTALI”, DANDO CONTO ANCHE DELLE PRINCIPALI FALSE OBIEZIONI POSTE A TALE INDISPENSABILE DEMARCAZIONE
La divisione (o “diversità”) tra i peccati che la Bibbia, la Tradizione cristiana e la retta ragione attestano è quella tra “mortali” (o “letali”) e veniali (o “lievi”). Occorre subito precisare, però, che in queste due categorie il termine “peccato” è utilizzato solo in senso analogico. Tra il peccato mortale e il veniale, infatti, esiste una similitudine limitata. Nelle rispettive condizioni ed effetti, piuttosto, si rinviene una profonda diversità, che non si riduce ad una maggiore o minore gravità, ad una differenza di grado, ma sono peccati in maniera essenzialmente diversa, perciò si parla nei loro confronti di distinzione teologica del peccato.
A questa netta distinzione sono state di recente opposte alcune critiche, dirette a introdurre una terza categoria di peccato, di tipo “intermedio” fra quello mortale e quello veniale, oppure di ridurre il peccato mortale ai soli atti di esplicito e formale disprezzo di Dio o del prossimo, detti di opzione fondamentale. Tali obiezioni alla dottrina tradizionale sono fondate su presupposti che possono essere così sintetizzati:
1) la divisione teologica dei peccati sarebbe stata proposta dagli autori scolastici esagerando la distinzione biblica e patristica al solo scopo di distinguere i peccati che si dovevano confessare da quelli che si potevano non confessare;
2) la nettezza nella distinzione ha finito per assimilare indebitamente il peccato grave a quello mortale;
3) la definizione come mortali dei peccati causati dalla fragilità umana appare sotto vari punti di vista impropria. Così, i peccati gravi che non sarebbero mortali, pur all’origine di gravi disordini nella vita morale, non porterebbero l’impronta dell’irrevocabilità a causa della debolezza umana.
Tutti questi tipi di argomentazioni, pur nella lodevole intenzione di chiarire una materia tanto delicata e importante, creano più problemi di quello che risolvono, soprattutto quando si richiamano a categorie e divisioni che non si prestano a verifica o controllo oggettivo, con il risultato di introdurre ulteriori cause d’incertezza.
Gli errori o equivoci sui quali si fondano riguardano:
1) una valutazione eccessiva, in termini antropologici, del processo di secolarizzazione in atto, che implicherebbe un invincibile affievolimento della conoscenza di Dio ed una parimenti irreversibile perdita del senso del peccato;
2) le conseguenze dei condizionamenti ambientali della società post-cristiana, i quali diminuirebbero la libertà umana, inibendo alla persona la capacità di modificare le intenzioni più profonde del suo agire particolare;
3) l’attribuzione della distinzione tradizionale dei peccati a un’invenzione di teologi scolastici, non storicamente sostenibile in quanto proclamata dalla Chiesa fin dall’età medievale e, soprattutto, fondata sull’insegnamento della S. Scrittura.
Il Magistero pontificio contemporaneo ha ribadito in più occasioni l’insegnamento tradizionale sulla divisione dei peccati. La distinzione essenziale e decisiva rimane infatti quella fra peccato che distrugge la carità e peccato che non uccide la vita soprannaturale: fra la vita e la morte non si dà via di mezzo. Allo stesso tempo, si dovrà evitare di ridurre il peccato mortale a un atto di “opzione fondamentale” poiché dalla considerazione della sfera psicologica non si può passare alla costituzione di una categoria teologica, con il rischio, di contribuire ad attenuare ancora di più, in un’epoca di scristianizzazione come l’attuale, il senso del peccato.
La debolezza umana e l’ignoranza involontaria possono sicuramente attenuare se non annullare l’imputabilità di una colpa grave ma, come precisa il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC), «si presume però che nessuno ignori i principi della legge morale che sono iscritti nella coscienza di ogni uomo» (n. 1860).
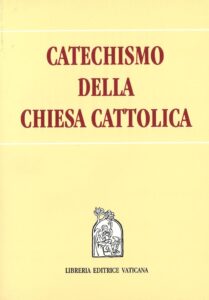
Possiamo dire che ogni peccato priva in qualche modo dell’amicizia con Dio. Tuttavia, il disordine generato da esso può essere più o meno grave a seconda dall’intensità della volontà nell’accettazione del disordine causato, il quale innalza una sorta di muro (od ostacolo) tra la persona e l’amore divino che, appunto, può essere più o meno elevato e incrementato con il ripetersi dell’azione od omissione peccaminosa.
Nella considerazione della gravità del peccato, la “materia” dell’atto immorale (vale a dire il suo contenuto) ha una valenza decisiva. Ciò in quanto un oggetto più grave richiede, generalmente, una maggiore volontarietà. In questo senso, l’importanza oggettiva di certi atti immorali comporta che, per sceglierli, sia necessaria un’intensità piena della volontà.
Non sempre è facile, nella concretezza delle situazioni, operare delle nette delimitazioni di confini tra comportamenti che danno luogo a peccati mortali o veniali. Nel ribadire l’importanza e la permanente attualità della distinzione tradizionale, l’Esortazione apostolica Reconciliatio et paenitentia ha specificato come, «già nell’Antico Testamento, per non pochi peccati – quelli commessi con deliberazione, le varie forme di impudicizia, di idolatria, di culto dei falsi dèi – si dichiarava che il reo doveva essere “eliminato dal suo popolo”, ciò che poteva anche significare condannato a morte. Ad essi si contrapponevano altri peccati, soprattutto quelli commessi per ignoranza, che venivano perdonati mediante un sacrificio» (n. 17).
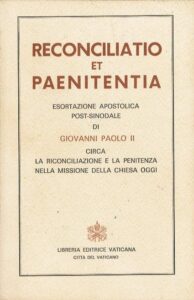
La distinzione tradizionale riceve il suo fondamento soprattutto nel Nuovo Testamento (cfr. ad es. 1Gv 5,16-17), che accentua l’incalcolabile gravità di ciò che è l’essenza del peccato, il rifiuto di Dio, che si attua soprattutto nell’apostasia e nell’idolatria, cioè nel ripudiare la fede nella verità rivelata e nell’equiparare a Dio certe realtà create, erigendole a idoli o falsi dèi. Nel Vangelo di Matteo (12,31s), è Gesù stesso a parlare di una «bestemmia contro lo Spirito Santo», la quale non può essere rimessa poiché si configura come un rifiuto ostinato di convertirsi.
Per aversi un peccato mortale si richiedono tre condizioni: che abbia per oggetto una materia grave, che venga commesso con piena consapevolezza e infine che sia voluto con deliberato consenso.
Per quanto riguarda la materia grave, essa è precisata dai Dieci comandamenti. Per quanto concerne le altre due condizioni, si tratta di porre in essere una così grave malizia da distruggere la vita di comunione con Dio e operare consapevolmente un atto di ribellione alla Sua volontà.
Mentre il peccato mortale distrugge la carità nel cuore dell’uomo a causa di una violazione grave della legge di Dio, il peccato veniale lascia sussistere la carità che, comunque, ne risulta in seguito ad esso offesa e ferita. Si commette un peccato veniale quando, trattandosi di materia leggera, non si osserva la misura prescritta dalla legge morale, oppure si disobbedisce alla legge morale in materia grave, ma senza piena consapevolezza e totale consenso.
Manifestando un affetto disordinato per dei beni creati, il peccato veniale ostacola i progressi dell’anima nell’esercizio delle virtù e nella pratica del bene morale e, qualora non confessato, dispone pian piano a commettere il peccato mortale.
Nel definire e distinguere i peccati mortali da quelli veniali, san Tommaso d’Aquino fa anche riferimento al concetto di morte spirituale. Secondo il Dottore Angelico, infatti, il peccato veniale non priva della grazia santificante e, quindi, della beatitudine eterna, mentre una tale privazione è conseguenza specifica del peccato mortale.
Gli effetti del peccato sono intimamente collegati con la sua essenza e collegati gli uni agli altri.
Il primo effetto del peccato mortale è l’esclusione dell’amicizia divina, l’aversio a Deo. Il peccato grave, infatti, priva dell’inabitazione delle tre Persone divine e pertanto della vita soprannaturale, della grazia santificante e della carità. Con il peccato mortale si perdono anche i meriti soprannaturali ottenuti, i quali si possono comunque recuperare quando il credente si penta ritornando all’amicizia con Dio.
L’effetto di qualsiasi mancanza alla Legge di Dio costituisce un danno che ricade direttamente sulla persona che la compie. Perdendo la comunione con Dio, infatti, l’uomo si mette in contraddizione con la propria tendenza originaria al bene, subisce la ribellione delle passioni e l’oscuramento della coscienza. La S. Scrittura, cui si accorda l’esperienza dei secoli, insegna che, una volta sconvolto l’ordine dei valori e mescolando il male col bene, gli individui e i gruppi guardano solamente agli interessi propri e non a quelli degli altri. Così il mondo cessa di essere il terreno di una genuina fraternità, mentre l’aumento della protervia umana minaccia di distruggere tutto e tutti.
La rottura radicale con Dio genera nella persona un insieme di scissioni che la rende infelice: il peccatore cerca la gioia, ma poiché la cerca in un posto sbagliato, quel che incontra è la tristezza, come dimostra la fine di Giuda il traditore.
Tutti i conflitti che si scatenano all’interno dell’uomo a causa della sua infedeltà producono in lui un sentimento di disagio, detto “rimorso della coscienza”, che può aiutarlo a pentirsi e ad espiare la pena dovuta dal peccato.
Considerando il peccato sotto l’aspetto della pena, san Tommaso d’Aquino definisce mortale il peccato che, se non rimesso, fa contrarre una pena eterna, veniale quello che merita una semplice pena temporale (cioè parziale ed espiabile in terra o nel purgatorio).

Nella Costituzione Benedictus Deus del 29 gennaio 1336, Papa Benedetto XII definisce ex-cathedra la verità relativa alla pena dell’inferno. Costituito da Dio in uno stato di giustizia, l’uomo tentato dal Maligno fin dagli inizi della storia ha abusato della libertà, erigendosi contro Dio e cercando di conseguire il suo fine al di fuori di Lui. All’inferno finiscono quindi coloro che preferiscono servire la creatura piuttosto che il Creatore. Morire in peccato mortale senza essersene pentiti e senza accogliere l’amore misericordioso di Dio, significa rimanere separati per sempre da lui per una propria libera scelta.
Nel Vangelo sono molti i riferimenti a questo stato di definitiva auto-esclusione dalla comunione con Dio e, Gesù, parla ripetutamente di “Geenna” e “fuoco inestinguibile”, che sono riservati a chi sino alla fine della vita rifiuta di credere e di convertirsi, e dove possono perire sia l’anima che il corpo. Le anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte discendono immediatamente negli inferi, dove subiscono le pene dell’inferno. La pena principale dell’inferno consiste nella separazione eterna da Dio, nel quale soltanto l’uomo può avere la vita e la felicità per le quali è stato creato.
A differenza di quanto affermato dall’eresia protestante, Dio non predestina nessuno ad andare all’inferno, in quanto tale stato è la conseguenza di una avversione volontaria a Dio (un peccato mortale), nella quale si persiste sino alla fine. Il Creatore vorrebbe piuttosto che tutti gli uomini siano salvati e vivano come suoi figli in Cristo (predestinazione alla salvezza). Anche se l’eternità dell’inferno ha sempre creato dubbi e suscitato paura negli uomini, i testi biblici sono inequivocabili e altrettanto chiaro è l’insegnamento costante della Chiesa.
In conclusione, la Chiesa propone come rimedio a qualsiasi rottura dell’amicizia con Dio la conversione individuale e il sacramento della confessione. Nella pratica pastorale e nella liturgia sono pertanto presenti, assieme all’azione penitenziale, la preghiera e il sacrificio per la conversione dei peccatori, attuati per mezzo della riparazione e dell’esercizio delle virtù.




