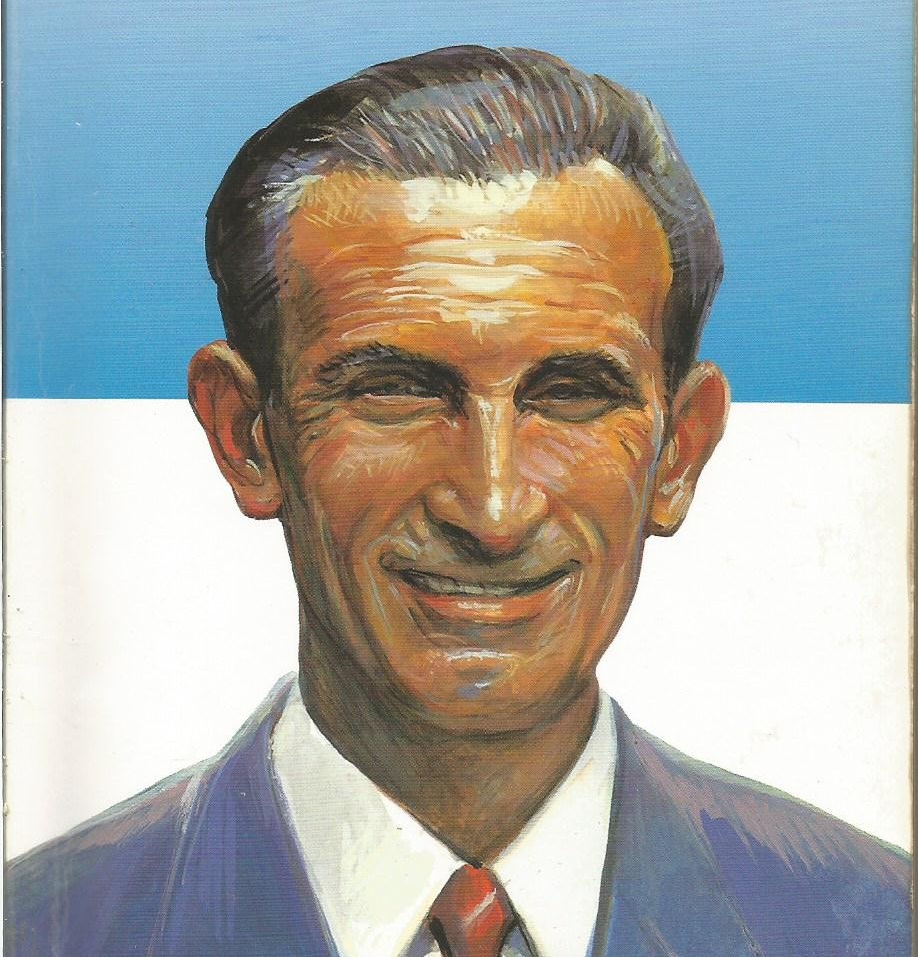Il libro di Giobbe: l’uomo e la sapienza di Dio
UNO DEI PRINCIPALI MESSAGGI TEOLOGICI CONTENUTI NEL LIBRO DI GIOBBE CONSISTE NEL SUPERAMENTO DELLA “TEORIA DELLA RETRIBUZIONE” (Gb 31,1-40). CON LA VITA DEL PATRIARCA, INFATTI, SI DIMOSTRA COME DIO NON PUNISCE SEMPRE SULLA TERRA COLORO CHE PECCANO E PERMETTE TALVOLTA LA SOFFERENZA DEL GIUSTO
–
Di Sara Deodati
Il libro di Giobbe, di autore anonimo, è stato composto probabilmente in un’epoca oscillante tra il VI e il V secolo a.C. Il brano di Gb 31,1-40, che dimostra come Dio non punisca sempre sulla terra coloro che peccano, costituisce il terzo capitolo della perorazione finale che conclude la difesa del patriarca (capp. 29-31). È preceduto dal ricordo nostalgico di un passato felice, ma ormai perso (l’amicizia con Dio, la gioia nella vita familiare, il prestigio e l’autorità nella vita pubblica, la fama, cap. 29) e dal confronto con la disgraziata situazione attuale (umiliazione e scherno da parte anche dei più giovani, ostilità e abbandono e sofferenza fisica, cap. 30).

Il capitolo 31 vede protagonista Giobbe nella sua arringa finale durante la quale emerge il profondo convincimento, più volte espresso agli amici, di essere giusto e irreprensibile (capp. 4-27). Così invoca un confronto con Dio, certo di poter rifiutare il decreto di condanna che Lo ha colpito. Nei capitoli successivi troviamo i discorsi di Eliu (capp. 32-37) che prepareranno la tanto attesa risposta di Dio (cap. 38). Se nei capitoli precedenti prevale un tono lirico, d’ora in poi prevarrà l’impostazione del discorso di tipo giudiziario. Dopo aver accusato il suo avversario, Giobbe proclama infatti la sua innocenza con un giuramento che, qualora non corrispondesse alla verità, si trasformerebbe in auto-maledizione.
Dopo il ritratto della felicità (cap. 29) e del dolore (cap. 30) trascorsi, emerge ora quello dell’uomo innocente, incentrato sulla sua virtù della giustizia. In questo modo il discorso assume completamente le caratteristiche del genere del giuramento imprecatorio contro sé stessi (cap. 31).

Questo intervento di Giobbe appare come una lunga protesta di innocenza, una “confessione negativa”, una specie di esame di coscienza sotto forma interrogativa e condizionale. Egli ricorre alla formulazione ipotetica che nella prima parte ha uno sviluppo iniziale positivo ed uno negativo formulato alternativamente in tali termini: “se ho commesso tale cosa”… oppure “se non ho osservato tale cosa”… Mentre nella frase positiva si dichiara la trasgressione della quale si giura di non essere colpevoli, in quella negativa si richiama una norma o un comportamento per il quale si giura che è stato osservato.
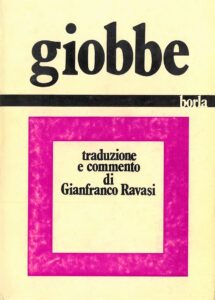
Essendo ogni giuramento legato strutturalmente ad una lista di delitti non commessi, accediamo alla suddivisione del card. Gianfranco Ravasi, secondo il quale sarebbero in Giobbe dodici, «ricalcando forse lo schema di alcuni dei dodecaloghi dell’alleanza basati sulla forma del diritto apodittico» (Giobbe. Traduzione e commento, Borla, Roma 1984, p. 641).

Lo schema in cui si può strutturare il capitolo analizzato può essere pertanto il seguente:
Gb 31,1-6, introduzione: la sfida di un cammino integro;
Gb 31,7-15, colpe di cupidigia e di ingiustizia:
– vv. 7-8 impurità,
– vv. 9-12 dissolutezza,
– vv. 13-15 diritti altrui;
Gb 31,16-22, peccati di omissione nei confronti degli altri:
– vv. 16-18 nutrire,
– vv. 19-20 vestire,
– vv. 21-22 diritto pervertito;
Gb 31,23, castigo incorso;
Gb 31,24-28 e Gb 38-40, tentazioni dell’orgoglio:
– vv. 24-25 argento,
– vv. 26-28 idolatria,
– vv. 38-40 suolo;
Gb 31,29-34, ingiustizie verso il nemico e lo straniero:
– vv. 29-30 vendetta,
– vv. 31-32 inospitalità,
– vv. 33-34 ipocrisia;
Gb 31,35-40, conclusione: l’ultima sfida.
Nell’introduzione Giobbe comincia con una formula generale, preliminare alla sua discolpa, interrogandosi sul vizio che il Decalogo chiama cupidigia. Poi fa un’allusione alla menzogna e alla falsità (vv. 5-6).
Nei vv. 7-15 considera gli atti che avrebbe potuto commettere per un desiderio smodato, esaminando partitamente tutte le possibili colpe riguardanti la giustizia verso il prossimo (frode, menzogna, adulterio, disprezzo del diritto etc.).
Nei vv. 16-23 l’esame di coscienza prosegue con l’elencazione delle ingiustizie verso i deboli, le vedove e gli orfani, che configurano negligenze della misericordia.
Nei vv. 24-28 Giobbe si interroga sui valori che hanno guidato la sua vita.
Nei vv. 29-34 torna con alcuni peccati di omissione che avrebbero potuto essere commessi contro il nemico e lo straniero.
Nei vv. 35-40 Giobbe riassume il suo comportamento di fronte a Dio.
Il capitolo 31 si apre con l’esplicito proposito, da parte di Giobbe, di non cadere nel peccato di adulterio neppure con gli occhi. Egli, infatti, ha stipulato un “patto con i suoi occhi” per non guardare una “vergine”. Infatti, l’eccitazione visiva è già il primo passo verso la consumazione di un rapporto fisico e, per questo, Giobbe raccomanda la sobrietà dello sguardo. Questo patto ha natura quasi formale e ciò è dimostrato dall’utilizzo dell’espressione tecnica karat berit, vale a dire «tagliare un patto». L’oggetto del trattato consisteva nel divieto di fissare con interesse e voluttà una vergine. Il v. 1 attesta che Giobbe non solo si è astenuto da questo peccato, ma ha anche cercato di conservare la purezza del cuore dimostrando di possedere una moralità che va oltre quella concepita al suo tempo.
I vv. 2-6 chiamano in causa direttamente Dio e i nomi divini che compaiono sono ēl e Sadday. Se ēl era già stato usato più volte nell’Antico Testamento indicando genericamente la divinità, Sadday ha un significato parzialmente oscuro, legato ad un elemento naturale che può essere reso con l’espressione: «Dio della montagna».
Nel v. 3 è ripetuta sotto forma di domanda retorica l’idea portante dell’autodifesa che Giobbe applica alla propria condizione: la retribuzione per cui la sventura piomba sull’empio e la sorte del malvagio si converte sempre in sciagura. Di qui gli interrogativi di Giobbe incredulo davanti ad una realtà nella quale Dio sembra un “contabile” lontano da qualsiasi sentimento di misericordia.

Nel v. 6 Giobbe inizia ad utilizzare la formula ‘im: “(se) ho fatto questo…mi succeda questa cosa”, che sarà ripetuta diciassette volte nel capitolo. Introduce quindi l’espressione di un giuramento in forma ipotetica, seguito da una formula imprecatoria con la quale egli applica a sé stesso la legge del taglione. La formula iniziale evoca il peccato di truffa con l’immagine della bilancia che invita alla pesatura del cuore del defunto, motivo ricorrente in Egitto sulla base del quale il destino dopo la morte dipende dall’equilibrio tra la benevolenza e la giustizia. Enunciata la colpa con l’introduzione in forma condizionale, Giobbe pronuncia nei suoi confronti un’auto-maledizione.
Il peccato che riguarda l’impostazione delle relazioni socioeconomiche, che ha due formulazioni nei vv. 5-6 e vv. 7-8, consiste nel falso agire con la mano e nel camminare in tutt’altra direzione col piede verso gli altri, ed è la descrizione di un atteggiamento di frode e falsità. La seconda formulazione del delitto presenta le falsità nate dall’invidia e dell’appropriazione indebita che Giobbe giura di non aver mai praticato.
Nella formula iniziale utilizzata nel v. 7, quindi, il “passo”, il “cuore”, gli “occhi” e la “mano” indicano l’impegno generale dell’uomo nel compiere il peccato con la seguente sequenza: gli occhi percepiscono una realtà come attraente, il cuore dà l’assenso e le mani eseguono quanto è maturato come scelta. Se, all’inizio del capitolo, Giobbe parlava dei suoi occhi come castigati esclusivamente in rapporto alla brama sessuale, qui aggiunge che nessun tipo di desiderio disordinato lo ha mai sopraffatto.
Nei vv. 9-12 viene descritto l’adulterio e le sue conseguenze negative, utilizzando il termine ‘issah in senso assoluto a differenza di quanto fatto nel v. 1 nel quale la giovane non ancora sposata è definita bᵉtûlāh (vergine) e la nozione di adulterio comporta lo stato civile di coniugata.
Nei vv. 10-11 si indica il verbo “macinare” con il significato dell’atto sessuale violento e il relativo delitto che va contro la Legge.
Nel v. 12 troviamo l’immagine del rogo quale punizione dell’adulterio e del fuoco della gelosia del marito tradito che si avventa contro l’uomo che ha consumato il rapporto con sua moglie.
Nei vv. 13-15 Giobbe afferma di non essersi mai macchiato del peccato della schiavitù e, anzi, di esser stato sempre molto attento nei confronti dei soggetti più deboli, in nome del principio della parità di condizione di tutti gli uomini davanti a Dio.
Dal v. 16 al v.18 inizia una serie di opere di misericordia: Giobbe dichiara di avere avuto a cuore in generale i poveri (dallîm) e, in particolare, le vedove (’almānāh) e gli orfani (yātȏm).
Al v. 19 appare un’altra categoria curata da Giobbe, ossia il viandante che è misero e quasi nudo, cui succede l’‘ebjon, ossia il mendicante circondato dall’amore di Giobbe. Quest’ultimo, infatti, ritiene di essere benedetto per quella benevolenza riservata da Dio a chi fa del bene ed è generoso con il povero.
Al v. 21 Giobbe ricorda l’ultimo personaggio bisognoso ossia l’innocente. Il contesto è quello processuale con l’impiego, ai vv. 22-23, dell’auto-maledizione: «Mi si stacchi il braccio della spalla e mi si rompa il gomito» se io mi alzo per attaccare un innocente.
Nel v. 25 si parla di “godere” con un termine che esprime il fare festa idolatrico con danze e riti che configurano quasi un nuovo culto pagano.
Nei vv. 26-28 c’è un richiamo all’idolatria esplicitamente evidenziato. La luce ’ȏr di cui si parla nel v. 26 è il sole il cui culto era diffuso nel mondo orientale insieme a quello della luna. Qui Giobbe evoca i gesti superstiziosi di un bacio e di un saluto che presuppongono la negazione a Dio della supremazia sul creato.

Nei vv. 29-30 si parla della vendetta, regolamentata in Israele dalla legge del taglione, come ennesima colpa sempre rifuggita da Giobbe. Gli è totalmente estraneo, infatti, il “piacere” provato dai malvagi di fronte alla caduta del proprio nemico, professando in tal modo tutta la sua mitezza.
Nei vv. 31-32 egli pone l’accento sull’ospitalità come segno della sua accoglienza verso tutti. Qui l’espressione “dare la propria carne per saziarsi” può essere uno sviluppo dell’espressione contenuta nel v. 17 dello “spartire il tozzo di pane” che Giobbe dichiara di aver utilizzato nei confronti dell’orfano Nel v. 32 troviamo i simboli di una ospitalità cordiale e generosa con l’espressione “dare la carne” (basar).
Nei vv. 33-34 emerge il comportamento di Giobbe avulso dallo scendere a patti con l’ipocrisia. A differenza di Adamo (Genesi 3,8-10) egli proclama di non voler mai mascherare la sua eventuale colpa tentando di giustificarsi come fatto invece dal “primo uomo”. Confessando la propria colpa, Giobbe è convinto che si possa dare lode a Dio anche dopo aver sbagliato, riconoscendo la verità e la giustizia divina.

I vv. 35-37 esprimono l’ultima parola di Giobbe (il tau è infatti l’ultima lettera dell’alfabeto ebraico scritta in forma di croce ed è un modo per firmare come a intendere: ecco la mia ultima parola!). La firma suggella la parola definitiva di Giobbe che non ha più nulla da aggiungere: da questo momento non prenderà più la parola tranne che per balbettare alla fine del libro un duplice accenno di risposta ai discorsi divini.
Nei vv. 38-/40 appare una incongruenza, ossia la caduta di tono successiva alla perorazione dei precedenti vv. 35-37 e la ripresa della disamina della moralità di Giobbe.
Il tema teologico centrale del cap. 31,1-40 gira intorno alla domanda sul perché Dio permetta la sofferenza del giusto. La sofferenza appare in vari passi di Giobbe come punizione per il peccato, sorgente di correzione morale, mezzo di conversione di purificazione e, infine, realtà che accolta sarà premiata con la vita eterna. La condotta di Giobbe è quella di uno che soffre e che si sente fremere dentro, conservando comunque la fiducia in Dio e nella Provvidenza.
La sua sofferenza non è la conseguenza diretta di un peccato personale, tanto che Dio stesso ne attesta l’integrità e la rettitudine. Dio dichiara esplicitamente l’inesattezza del ragionamento dei tre amici, i quali sostenevano che Giobbe fosse stato punito per i suoi peccati. Sebbene la sua sofferenza non fosse una conseguenza del peccato, le prove che egli patì rivelarono, in effetti, la presunzione, l’autoassoluzione e il malanimo che egli covava in cuore. Giobbe non fu libero finché non raggiunse una chiara visione della propria nullità e della grandezza di Dio e non ebbe pregato per i propri amici. In tal modo la sofferenza del giusto è diventata occasione per un nuovo concetto di retribuzione che, finora nell’Antico Testamento, si fondava su una logica di “dare-avere”: se uno è buono avrà il bene, se è cattivo gli toccherà in sorte il male.

Il dibattito interiore di Giobbe nel cap. 31,1-40, in definitiva, è centrato sulla speranza, che egli non possiede, ma che è invitato a vivere come una grazia che mette alla prova e purifica. Essa si appoggia sulla sua fede nel Dio giusto e buono che ha fatto il mondo. Tale certezza smonta la teoria tradizionale della retribuzione: Giobbe infatti alla fine saprà di esser stato nuovamente benedetto da Dio perché gli viene restituito quello che aveva e molto di più.
Dopo aver parlato con Dio raggiunge quindi la pace del cuore per aver definitivamente compreso che la Sua giustizia è al di sopra della nostra intelligenza e, quello della sofferenza del giusto, costituisce ancora un mistero da accettare anche da parte di tutti noi.
La sofferenza del giusto può essere considerato il concetto-chiave dell’intero libro di Giobbe. Il sofferente si dimostrerà infatti giusto solo perché davanti alle numerose, dolorose e intense prove con cui verrà tentato, riuscirà a rimanere fedele a Dio.