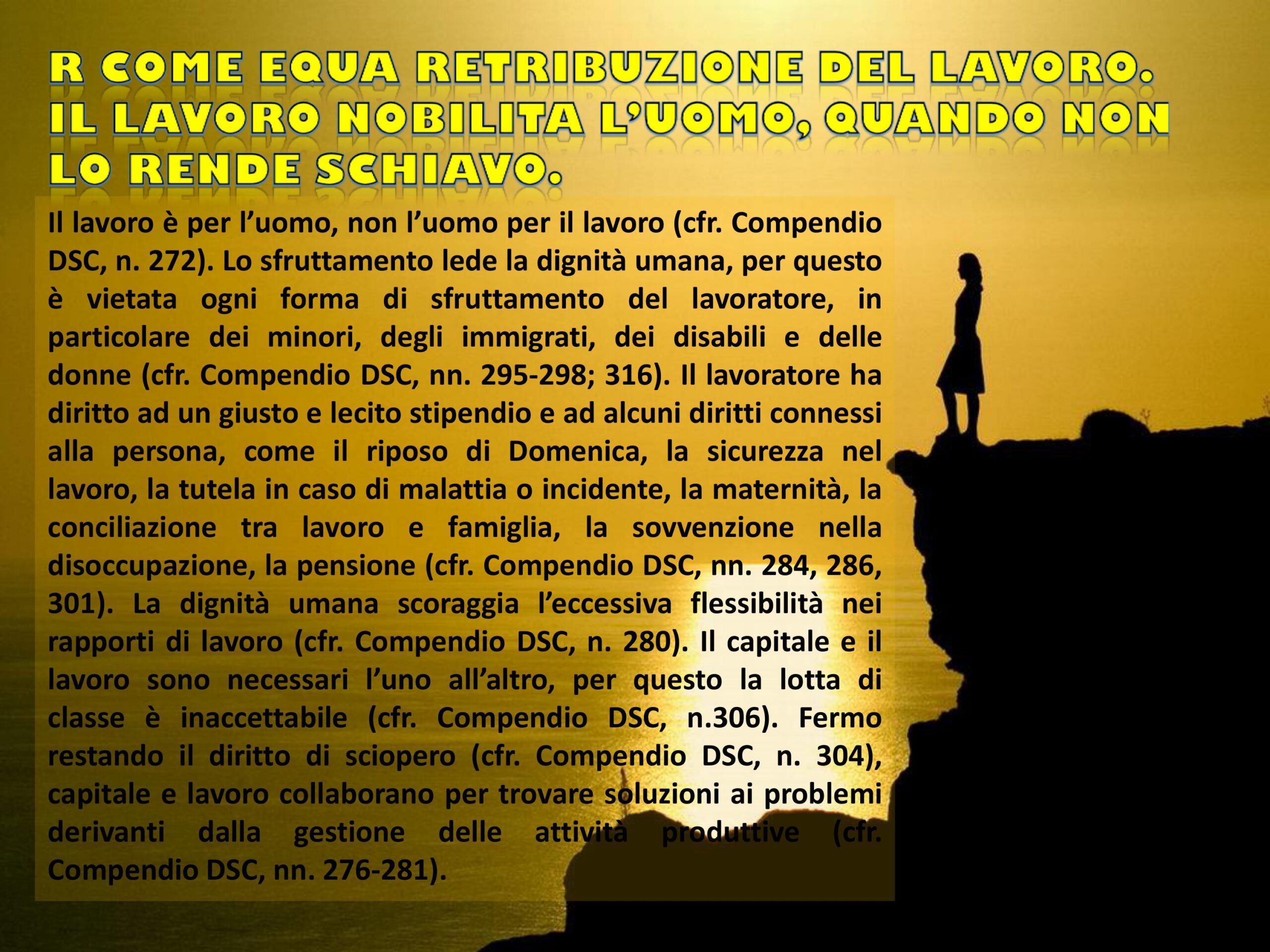“R” come equa retribuzione del lavoro, anche quello domestico
OGGI SPESSO LA DONNA LAVORA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O NEL PRIVATO, PERCEPENDO UNO STIPENDIO PARI A QUELLO DEL MARITO O CONVIVENTE. TALE CONDIZIONE CONSENTE ALLA LAVORATREICE NON SOLO DI RENDERSI INDIPENDENTE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO, MA ANCHE DI PERSEGUIRE UNA CARRIERA PROFESSIONALE CHE NON È PIÙ PREROGATIVA ESCLUSIVA DEI “MASCHI”. NONOSTANTE CIÒ, IN ITALIA TROVIAMO ANCORA UNA LARGA FETTA DI MOGLI E/O MADRI CHE, D’ACCORDO CON IL PROPRIO CONIUGE, PREFERISCE DEDICARSI ESCLUSIVAMENTE ALLA CASA, ALL’ASSISTENZA DEI PROPRI CARI E, QUANDO CI SONO, AI FIGLI. TALE INESTIMABILE ATTIVITÀ, UNA VERA E PROPRIA “MISSIONE”, PER QUANTO NON RIDUCIBILE AD ASPETTI QUANTITATIVI, DOVREBBE PERÒ ALMENO AVERE UN RICONOSCIMENTO ECONOMICO-PREVIDENZIALE
–
Di Giuseppe Brienza*
Il lavoro, come afferma sulla base dell’insegnamento di Gesù il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, è per l’uomo, non l’uomo per il lavoro (cfr. n. 272). Il lavoratore ha diritto ad un giusto e lecito stipendio e ad alcuni diritti connessi alla persona, come il riposo domenicale e festivo, la sicurezza sui luoghi lavorativi, la tutela in caso di malattia o incidente, la maternità, la conciliazione tra lavoro e famiglia, la sovvenzione nella disoccupazione, la pensione, compresa quella di reversibilità (cfr. Compendio DSC, nn. 284, 286, 301). La dignità umana scoraggia l’eccessiva flessibilità nei rapporti di lavoro (cfr. Compendio DSC, n. 280) e, fermo restando il diritto di sciopero (cfr. Compendio DSC, n. 304), capitale e lavoro collaborano per trovare soluzioni ai problemi derivanti dalla gestione delle attività produttive (cfr. Compendio DSC, nn. 276-281).
Tra le questioni ancora aperte da oltre due secoli, ovvero a partire dall’inizio delle varie rivoluzioni industriali, rimane quella della donna-casalinga e del c.d. lavoro familiare, sebbene la cura esclusiva del proprio nucleo coniugale non sia propriamente un “lavoro” ma, innanzitutto, una “missione”. Essendo in un sistema che trova riflessi (e tutele) economico-sociali un po’ ovunque, sarebbe il caso di porre nuova attenzione alla vera “categoria” discriminata e fragile ancora oggi nel XXI secolo, ovvero la moglie e madre “non lavoratrice”. È difficile, infatti, contestarne il ruolo, ed anche la valenza nazionale tanto a livello economico quanto sociale.
Se per “lavoro familiare” (dizione da preferirsi a quella meno significativa di “lavoro domestico”) si intendono tutte quelle attività di manutenzione e trasformazione dei beni di consumo a livello domestico, di educazione e cura dei membri della famiglia (nonché mediazione tra questi ultimi ed i servizi sociali), svolte nell’ambito del nucleo familiare “ampliamente inteso”, questo tipo di “servizi” possono e debbono essere stimati anche nel loro valore economico, sebbene sia riduttivo e, in certo senso, “perverso”, pensare di esaurirli in una semplice monetizzazione.
Personalmente, da studioso delle politiche familiari, ho ritenuto anch’io di ribadire, in un saggio, che le attività che rientrano nel “lavoro” di una mamma «producono innanzitutto rapporti sociali, che “non possono essere frazionati, scissi, mercificati, ridotti al di là di un certo limite, senza provocare perdite di comunicazione umana che, alla fine, hanno effetti globali molto più negativi di quanti non siano i pochi vantaggi ottenuti dalla loro conversione in un valore, di uso o di scambio”» (GIUSEPPE BRIENZA, Famiglia e politiche familiari in Italia, Carocci Editore, Roma 2001, p. 75).
Detto questo, però, dobbiamo ricordare che un riconoscimento giurisprudenziale del “lavoro familiare” si è avuto, nell’ambito dell’attuale ordinamento repubblicano, fin dalla sentenza n.28/1995 della Corte costituzionale, con la quale l’attività svolta in casa è definita come un vero e proprio “lavoro”. Secondo la Consulta, infatti, esso va «ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l’art. 35 della Costituzione assicura al lavoro “in tutte le sue forme”». I giudici costituzionali richiamavano al proposito, fra gli altri, anche l’art. 230 bis del Codice civile (introdotto dalla l. n. 151/1975), il quale, «apportando una specifica garanzia al familiare che, lavorando nell’ambito della famiglia o nell’impresa familiare, presta in modo continuativo la sua attività, mostra di considerare in linea di principio il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua del lavoro prestato nell’impresa» (sent. n. 28/1995). Facendo suoi questi autorevoli richiami, l’allora Ministro della Famiglia e della solidarietà sociale Adriano Ossicini (1920-2019), già ordinario di psicologia all’Università “La Sapienza” di Roma e fondatore nel 1947, insieme al padre della moderna neuropsichiatria infantile Giovanni Bollea (1913-2011), del primo Centro medico-psico-pedagogico (CMPP) d’Italia, propose nell’ambito del Governo Dini (1995-96) l’adozione di una forma di «salario per le casalinghe». Si badi, anche se la proposta fu avanzata “da sinistra” (il prof. Ossicini è noto per esser stato eletto, nel 1968, al Senato come indipendente nelle liste del PCI e, da ultimo, ha aderito fin al Partito Democratico), non alcun ebbe esito. La stessa, però, come ho avuto modo di argomentare, «influenzò sicuramente la legge di riforma delle pensioni, approvata di lì a poco (l. n. 335/1995). Essa prevedeva infatti, una delega all’esecutivo per l’emanazione, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, di norme volte a rendere finalmente applicabile la disciplina sulle pensioni a favore delle casalinghe introdotta (nominalmente) fin dalla l. n. 389/1965. Il Governo istituì così, con la l. n. 565/1996, il “Fondo mutualità pensioni per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”, a decorrere dal 01/01/1997. Questo Fondo, di fatto, non è stato ancora finanziato, e della sua esistenza si comincia dunque a dubitare…» (G. BRIENZA, Famiglia e politiche familiari in Italia, op. cit., p. 76).
Detto questo andrebbe anche ricordato che, in Italia, la prima forma di tutela previdenziale riguardante le casalinghe si rinviene nell’art. 85 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155. Il rapporto assicurativo previdenziale era però attuato su richiesta del soggetto interessato all’iscrizione e senza discrezionalità di sorta da parte dell’ente previdenziale che non poteva far altro che iscrivere. Successivamente la legge 5 marzo 1963, n. 389 istituì presso l’I.N.P.S. la gestione separata “Mutualità Pensioni” avente lo scopo di gestire l’assicurazione volontaria per le pensioni delle casalinghe (art.1). I soggetti iscrivibili alla gestione erano individuati nelle persone di sesso femminile che avessero compiuto il quindicesimo anno di età e che non avessero superato il 50° anno, o che risultassero iscritte all’assicurazione facoltativa istituita dal citato articolo 85, e in ogni caso, che fossero iscritte a forme previdenziali obbligatorie.
La materia subisce, come detto, l’ulteriore evoluzione di cui abbiamo appena accennato con la delega contenuta nel comma 33° dell’art. 2 della “legge Dini”. Al di là della questione della “pensione alle casalinghe”, comunque, va affermato che negli ultimi decenni la giurisprudenza ha ormai attribuito, sebbene in termini “rivendicativi” ed economicistici e non di valorizzazione sociale, al “lavoro familiare” una serie di garanzie pari a quelle di qualsiasi altro lavoro pubblico o privato. Lo si può dedurre dai seguenti due aspetti: «a) Il primo: se la casalinga si infortuna in un incidente stradale, il marito ha diritto a un risarcimento anche di natura economica, per aver perso il supporto in famiglia ed essere costretto a ricorrere a una collaboratrice esterna. La giurisprudenza ha, infatti, riconosciuto il danno patrimoniale per la perdita del contributo domestico (anche se solo per un periodo limitato di tempo) che la moglie è in grado di dare. b) Il secondo: al momento della separazione della coppia, la donna che ha svolto il ruolo della casalinga ha diritto a un assegno di mantenimento proporzionato al sacrificio e al contributo da questa prestato alla famiglia. Questa importante precisazione è stata fornita dalla Cassazione a Sezioni Unite nel luglio del 2018. Attenzione però: il lavoro di casalinga è tale solo se concordato con il marito. In buona sostanza, non deve risultare che l’attività domestica sia solo la scusa per evitare gli impegni lavorativi» (Moglie casalinga: ha diritto a parte dello stipendio del marito?, in La Legge per tutti, 7 giugno 2020).
Siccome siamo alla vigilia di una fase storica e sociale nella quale si ripete spesso che “niente sarà più come prima”, perché non ritrovare nel favor familiae che passa attraverso la rivalutazione del ruolo esclusivo (ma naturalmente volontario) di moglie e madre una delle risposte alla più grave crisi sanitaria ed economica che la Repubblica abbia mai vissuto?
———–
* Vedi qui il canale YouTube curato dall’autore di questo articolo: Temi di Dottrina sociale della Chiesa.