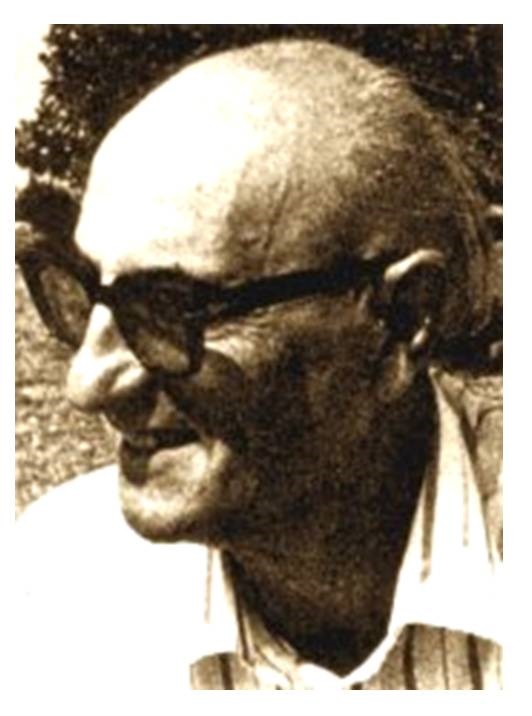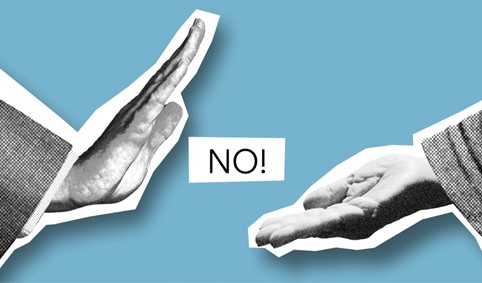Ecco perché la stampa di sinistra si è appropriata indebitamente di Gesualdo Bufalino

Di Valerio Pece
Lo scorso 15 novembre Gesualdo Bufalino (1920-2020) avrebbe compiuto 100 anni.
La stampa di sinistra ha celebrato il pluripremiato scrittore siciliano appropriandosene indebitamente, chiudendo gli occhi sulla sua anima conservatrice (cara a Montanelli) e sull’“ossessione metafisica” che non l’ha mai abbandonato.
“U prufissuri”. Così nella sua Comiso, «piccolo borgo dal nome sdrucciolo, fra gl’Iblei e il mare», la gente chiamava Gesualdo Bufalino, per venticinque anni insegnante di italiano e storia nel ragusano. Tutti conoscevano la sua passione per i libri ma nessuno immaginava che, chiuso in un cassetto, nascondesse un romanzo che l’avrebbe reso famoso: Diceria dell’untore, vincitore nel 1981 di un meritatissimo premio Campiello.
«BAUDELAIRE RINASCE A COMISO»
Il riconoscimento non mutò solo il destino del già sessantunenne scrittore – che da allora, con l’inconfondibile e anticheggiante “stile bufalino” ruppe gli indugi e inaugurò un quindicennio di intensissima attività letteraria – ma anche quello della Sellerio, piccola casa editrice di Palermo, che proprio sulla scia di quel romanzo (con le sue svariate traduzioni e il film che ne seguì) si lanciò verso confini nazionali. Complici del successo, il fiuto e soprattutto l’insistenza di Elvira Sellerio e Leonardo Sciascia, i quali dovettero lottare non poco per vincere le resistenze di un pudico Bufalino che continuava a sconsigliare la pubblicazione del romanzo.
Pubblico e critica si innamorano immediatamente di questo siciliano colto e schivo, il cui strabismo sarebbe piaciuto a Piero della Francesca; e ben prima dell’uscita dell’altro suo capolavoro, Le Menzogne della notte, destinato a vincere lo Strega, cominciarono a fioccare entusiasti titoli di giornali: «Bufalino, il caso dell’anno», «Che Maestro questo don Gesualdo», «Un altro Gattopardo?», «Bufalino esordiente scontroso: a 18 anni giocavo col Melzi», «Bufalino cento e lode», «Storia di un letterato di provincia raggiunto da inevitabile successo», «Baudelaire rinasce a Comiso», «Mastro Don Gesualdo». Un trionfo.
UN ESERCITO DI MAESTRI ELEMENTARI CONTRO LA MAFIA
Come i suoi corregionali, dagli attivissimi Consolo e Camilleri fino ai lontani Capuana e Verga, passando per Tomasi di Lampedusa, Pirandello, Vittorini, Sciascia e Brancati, anche Gesualdo Bufalino non ha mancato di cantare le “cento Sicilie”. Ma a differenza loro, lui, della Sicilia, non è mai stato considerato “la coscienza”.
Sull’ineludibile questione mafia, ad esempio, allo scrittore è stato rinfacciato uno scarso impegno civile, gli è stato rimproverato più o meno sottilmente di non essere come Sciascia. Ma a ben vedere, pur non incarnando fortunatamente la classica figura d’intellettuale engagé, Bufalino non si mai sottratto dal trattare questioni sociali, anche scottanti. Semplicemente, l’ha fatto utilizzando le sue corde, meno ideologiche ma non meno civili e persuasive. «M’è venuto detto una volta – scriveva lo scrittore – d’avere imparato a non rubare ascoltando Mozart», in trasparenza qui c’è già tutta la sua limpida ricetta. Per Bufalino sconfiggere la mafia significava debellare quello che chiamava «l’analfabetismo morale», pensiero suffragato da quella frase (quanto saccheggiata!) pronunciata all’indomani della strage che uccise Falcone: «Per sconfiggere la mafia è necessario un esercito di maestri elementari».
I MISSILI NATO E I “SANTONI DELLA PACE”
Benché – anche qui – non gli sia stato mai realmente perdonato, Bufalino si era sempre tenuto lontano dalla politica, mai occupandosene, se non in qualche fortuita incursione. Come quella, curiosa, sopraggiunta nel ’92, quando la rivista culturale «L’Indice», volendo burlarsi di una Lega allora fortemente secessionista, pubblicò una foto di Sciascia e Bufalino con questo titolo: «I terroni: pur di non lavorare scrivono». Toccato sulla sua sicilianità, quella volta Bufalino cedette, e Bossi fu classificato come «un fritto misto tra il feroce Saladino e Capitan Fracassa». Ma fu, appunto, nient’altro che un’incursione indotta.
Anche quando Comiso, nei primi anni ’80, divenne sede di una base missilistica della Nato, Bufalino si smarcò subito da comodi posizionamenti, ben conscio che la pace non sarebbe arrivata da pacifisti smaniosi soltanto di disarmi unilaterali. Non ci voleva certo molto a capire che con l’arrivo dei missili Cruise la sua Comiso rischiasse d’essere, come scrisse, «sbattezzata e invasa». Ma per evitare che in questo centesimo anniversario della nascita di Bufalino, a qualcuno venisse in mente di impossessarsene politicamente, è appena il caso di conoscere il giudizio dello scrittore su quella “doppia intrusione”. «Da un lato – scriveva in quei giorni caldi Bufalino – soldati, tecnici, salmerie, congegni, tutto un apparato di inodora, insapora, luccicante efficienza; dall’altro i pittoreschi, sbrindellati, ora miti ora protervi, ora salmodianti ora maledicenti, partigiani e santoni di pace che in buona o mala, in ottima o pessima fede, sono qui accorsi da tutte le parti del mondo». E ancora: «una Corte dei Miracoli, la quale, sia che ripugni, sia che insospettisca, sia che commuova, pare anch’essa risoluta ad accamparsi senza limite di tempo sui nostri marciapiedi e le nostre soglie».
Malgrado la sua prosa rara e lussureggiante, malgrado gli Strega e i Campiello vinti, con queste sue tesi politicamente scorrette – incredibile ma vero – per Bufalino non c’erano molti spazi su cui scrivere. Per molto tempo, quindi, i suoi raffinati elzeviri su costume e società lo scrittore li affidò a una delle pochissime voci libere, al «Giornale» di quel Montanelli che del professore siciliano era gelosissimo. E a cui, tra l’altro, somigliava: entrambi goffamente allampanati, entrambi – a scriverlo è Bufalino – «dai nervi e dalla coronarie di carta velina».
L’OSSESSIONE METAFISICA
Ma in quest’anniversario bufaliniano ciò che sarebbe davvero interessante recuperare, è la sua “ossessione metafisica”. Il dissidio tra arte e realtà (snodo squisitamente novecentesco), e i risvolti misterici tra malattia e vita (lui malato di tisi, con anni passati in sanatorio), pur presenti nella sua produzione letteraria, altro non erano che un semplice corollario della questione veramente inseguita per una vita dallo scrittore: Dio.
Anche il suo personalissimo stile neobarocco ne era un chiaro sintomo; lui stesso ammetterà: «E dopotutto il registro alto, lo scialo degli aggettivi, l’oltranza dei colori mi pare il modo che ci resta per contrastare l’ossificazione del mondo (…) e per restituire ai nostri occhi ormai miopi il sangue forte delle presenze e dei sentimenti».
Al brianzolo Angelo Romanò, giovane intellettuale cattolico con cui Bufalino ha intessuto uno struggente carteggio, riguardo a Cristo scriverà parole fortissime: «Tu sai da quanto tempo Egli non è più nel mio cuore un inesplicabile ospite dalle mani di luce, ma il concitato rivale contro cui si va allo sbaraglio, in un duello funesto e sacro. Tu sai anche con quale disperata speranza io insisto a eludere la mia triste vocazione di triste eresiarca, e tento di restituire ai miei giorni un senso che non sia quello d’una bestemmia taciuta e vigliacca». Il «duello funesto e sacro» e la «disperata speranza» non sono altro che il lucignolo fumigante, che non si spegne, e il sincero tormento bufaliniano sembra proprio giocarsi tutto dentro e non fuori una chiara dimensione religiosa. Seppur si debba parlare, per stare alle parole della sua autobiografia, di «un cristianesimo ateo e tremante».
È l’ineludibile lotta con Dio, fatta a colpi di domande («Se Dio esiste, chi è? Se non esiste, chi siamo?») che farà dire a Bufalino: «Bisogna che abbiamo un’idea molto primitiva dell’eternità se facciamo tanto caso del morire a trenta o a cent’anni».